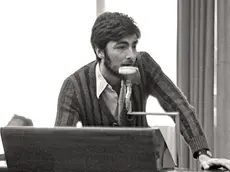Giordana Panegos: «Nella Baberia eravamo libere»

TRIESTE «Il ’68 mi ha trasformato completamente nel giro di un inverno: con l’iscrizione all’Università di Trieste ho cambiato città e vita. Mi ricordo ancora la prima valigia che feci, aiutata dalla mamma, la prima delle numerose domeniche che per tutto il periodo dell’università scandirono la mia vita, il treno delle 6 che era l’unico diretto da Pordenone a Trieste. Non avevo mai viaggiato da sola e la seconda volta che presi il treno per recarmi a Trieste mi rubarono il cappotto: me ne accorsi soltanto una volta arrivata alla stazione». Per Giordana Panegos il movimento del ’68 e gli anni dell’università segnarono l’emancipazione dalla famiglia e le insegnarono un nuovo approccio al mondo, che si concretizzò in tutto il suo operato successivo.
Psicologa e docente, dopo una breve militanza in politica ha messo al centro della sua vita i bambini: ha iniziato a fare terapia ai bimbi non vedenti, per poi insegnare alla scuola media e infine aprire con un gruppo di colleghe la cooperativa Melarancia, che si occupa di servizi per l’infanzia. «In quegli anni ho imparato la necessità di abbattere i pregiudizi e ribadire il diritto alla differenza come indispensabile per la valorizzazione del talento di ciascuno - racconta -. Quando sento insegnanti affermare che per loro i bambini sono tutti uguali, penso che dicano qualcosa di molto sbagliato: i bambini sono diversi e trattarli come fossero tutti uguali è una vera ingiustizia».
Come iniziò il suo ’68 triestino?
«Quando arrivai per la prima volta a Trieste - racconta Giordana Panegos -, iscritta al primo anno del corso di laurea in Filosofia, c’era già un bel po’ di movimento tra quelle mura: poco dopo il mio arrivo iniziò l’occupazione a Lettere. Ero una delle poche studentesse di Pordenone iscritte a Trieste, la maggior parte di noi sceglieva Padova. Fra Trieste che scoprii di essere “furlana” e se anche io parlavo il mio dialetto veneto questo fattore sembrava non comportare differenze per i miei nuovi amici. Volevo studiare psicologia e ancora non c’era un corso di laurea, ma a Filosofia c’era l’Istituto di Psicologia, e anche al suo interno vi era parecchio movimento».
Che caratteristiche aveva questo Istituto?
«L’aveva fondato Gaetano Kanizsa e aveva una solida tradizione di psicologia sperimentale. Nell’Istituto stesso in quegli anni le dinamiche interne si modificarono: c’erano alcuni docenti, penso al professor Bozzi che veniva da Trento, che favorirono altre esperienze, come la partecipazione al movimento per l’apertura dell’ospedale psichiatrico. La possibilità di sperimentare spaziando tra le altre discipline fu una conquista di quegli anni, resa possibile dall’apertura dei piani di studio: fino a quel momento l’impostazione era stata piuttosto rigida. Credo sia stata indispensabile per creare una mentalità differente rispetto al passato».
Quando si trasferì a Trieste dove andò a vivere?
«All’inizio andai ad abitare in un collegio di suore, a Scorcola. Lo decisi all’ultimo momento e quando mi trasferii mio padre mi mise in guardia: “Io non ci andrei - mi disse -, ma devi promettermi che se lo fai poi ci resterai fino alla fine dell’anno”. Non si era sbagliato nella sua previsione. Ressi fino a primavera, poi andai a vivere con un’altra studentessa in una stanza vicino alla stazione: dissi ai miei, e loro finsero di crederci, che era una soluzione per le riunioni serali richieste dai lavori di gruppo».
Come nacque l’idea della Baberia?
«Verso fine anno conobbi altre studentesse, tutte friulane, con cui diventammo amiche: Anna, Cristina e le due Patrizie, Daniela. L’anno successivo prendemmo in affitto insieme un appartamento in via Giulia: era al pianterreno e le finestre davano sulla strada. Al suo interno c’era un atrio scuro, una grande cucina, un bagno e tre camere, che ci dividemmo. Organizzavamo delle cene e ospitavamo spesso altri ragazzi e ragazze, studiavamo insieme, vivevamo scambiandoci esperienze e confidenze. Ci soprannominammo “Baberia” perché un appartamento di sette ragazze in quegli anni era una vera e propria rarità e perché questo suono “triestino” ci piacque tantissimo. Furono in tanti ad arrampicarsi per entrare dalle finestre di quell’appartamento sui generis: Roberto, Nico, Marco, Gino erano giovanissimi, ci raccontavano dei problemi della scuola e passavamo serate intere a confrontarci sulla vita che avremmo avuto».
Come reagì la sua famiglia?
«I miei genitori erano molto laici e moderni, ma a quei tempi l’educazione per le ragazze era molto rigida. Nei fine settimana litigavo con mio papà dal venerdì sera fino al momento della mia ripartenza. Ma pur non condividendo le mie scelte i miei erano persone intelligenti: la loro maggiore preoccupazione era che potessi scegliere una strada non adatta a me per ribellione. Quando raccontai loro della grande occupazione dell’Università Nuova mio padre mi disse: “Se arriva la polizia cerca almeno di non essere la prima a finire dentro”. Vi furono situazioni di grande contrasto con loro, ma sono molto grata ai miei genitori, che con questo atteggiamento mi aiutarono a mediare rispetto ad alcune ribellioni totali della mia generazione, nelle esperienze che andavo vivendo».
Cosa ricorda del femminismo a Trieste?
«A Trieste c’erano diversi gruppi femministi, ma io ero affascinata dalle donne dell’Udi, con cui entrai in contatto nei primi anni ’70: più vecchie di me, portavano con sé storie di vita e scelte di autonomia. Storicamente le triestine erano sempre state più libere rispetto alla cultura da cui provenivo: ai tempi dell’Università andavo al mare al Pedocin e lì trovavo donne che mi raccontavano esperienze di vita straordinarie. A Pordenone non ci si sedeva neanche nelle sedie fuori dai bar, si figuri che impatto fu per me arrivare a Trieste e vedere donne anziane prendere il sole al mare al solarium, nude. Era anche questa una libertà basata sulla possibilità per il singolo di decidere quello che è giusto per sé.
Molto più tardi scelsi di partorire mia figlia al Burlo e quando mi recai per un controllo a Pordenone le infermiere videro la mia pancia cosi abbronzata e mi ammonirono, ma quando le interrogai sulle ragioni per cui fosse sconsigliato prendere il sole in gravidanza non mi seppero rispondere. Pensandoci adesso all’università il movimento era prettamente maschile, ma tra noi c’era molta amicizia e solidarietà e discutevamo di temi che ci riguardavano da vicino: la libertà di scelta, le nostre paure. Il cambiamento più profondo della nostra società ha molto a che fare con la battaglia delle donne. Ebbi molta nostalgia degli anni triestini quando, finita l’università, tornai a Pordenone: a quel tempo ero iscritta al Pci, ma nei partiti i maschi non erano pronti a farci spazio. Alla fine decisi di uscire dalla politica vera e propria. In fondo era quello che avevamo capito durante l’università: che si poteva fare il proprio lavoro mettendoci dentro passione e idee e che questo era un modo importante di fare politica».
Cosa si portò dietro del ‘68?
«Il mio modo di intendere la vita, credo… Ho insegnato mettendo al bando l’autoritarismo e promuovendo le libere scelte, la possibilità per tutti di esprimersi nello spazio. Amo il ’68 perché da allora le cose non sono state più uguali. Abbiamo ottenuto diritti importanti, dal divorzio all’abolizione delle scuole speciali, dall’aborto alla legge sulla salute mentale, che hanno cambiato profondamente il nostro modo di stare in società, dando voce a chi non l’aveva mai avuta: le donne, i bambini, i malati psichiatrici. E sono molto legata alle persone che vissero quel periodo con me: volevamo costruire un mondo di libertà e in verità io non subii mai costrizioni di alcun tipo, anzi sperimentai uno spazio in cui potevo muovermi come volevo. Con la libertà di decidere ho sperimentato la bellezza dell’assunzione della propria responsabilità».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo