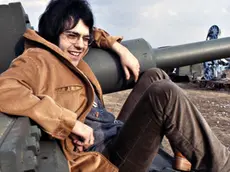Sergio Grmek Germani: «Attraverso il cinema una protesta estetica»

TRIESTE «Per la diffusione del cinema a Trieste il periodo che ruotò intorno al ’68 fu particolarmente prolifico: grazie alle attività dei cineclub, talvolta collegate con i circoli di cultura politica, furono davvero tante le persone che si avvicinarono alla settima arte. Nel periodo immediatamente successivo nacque all’Università di Trieste la prima cattedra di storia del cinema, che diede un impulso straordinario anche all’idea di far nascere dei festival cinematografici in città». Racconta così Sergio Germani il grande fermento culturale del Sessantotto triestino. Per lui, nato nel 1950, Cosulich, Kezich e Ranieri, che come Franco Giraldi partivano da posizioni politiche di sinistra ma avevano un’idea completamente libera e non dogmatica della ricerca cinematografica, furono tra le figure di riferimento. Ma li conobbe personalmente solo negli anni successivi, perché con Trieste ormai non avevano più molti rapporti. Nel ’68-‘69 Germani affrontò il passaggio dal liceo all’università, partecipò al movimento studentesco e soprattutto si fece coinvolgere in tutte le diverse esperienze di cineclub che nacquero in quel periodo.
Come iniziò il suo ’68?
«Nel ’68 ero all’ultimo anno del liceo classico Prešeren e feci parte di quel gruppo di studenti che diedero il via al movimento studentesco nella scuola slovena. A settembre vi fu il passaggio all’università, con l’iscrizione al primo anno del corso di Filosofia alla facoltà di Lettere dell’Università vecchia. Ma per quanto fosse importante il riferimento alla dimensione scolastica, non ebbi mai la percezione che il discorso sul ’68 si riferisse soprattutto alla scuola o unicamente al ringiovanimento generazionale. Per me le tendenze politiche del ’68, come ha già sottolineato Claudio Venza nella prima intervista di questa serie, ebbero forti radici in una tradizione libertaria o eretica che era già nata in precedenza, con Umberto Tommasini, Raniero Panzieri e Danilo Montaldi, che sono stati dei veri maestri, anche se in quel periodo non si cercavano figure di riferimento nel passato».
E i maestri nel percorso di studi?
«Persone dalla mente molto libera ne incontrai prima al liceo, con Boris Pahor e Alojz Rebula, quindi all’università. Oltre alle figure più vicine politicamente al movimento, come i docenti del corso di Storia, ricordo Giorgio Radetti a Filosofia, che diceva: “Marx è uno che prima ti sveglia e poi ti addormenta”, una riflessione ad alta voce che riguardava anche il suo rapporto con la filosofia. Ecco, per me il ’68 fu soprattutto un modo per combattere una dimensione oppressiva, più che sul piano del sapere, sul piano sociale, e si collegava con le attività che già da metà degli anni ’60 avevo avviato in ambito cinematografico».
Nacque allora la sua passione per il cinema?
«No, l’amore per il cinema era nato già nell’infanzia, grazie ai miei genitori. All’epoca abitavo a Prosecco e tra questo e Contovello c’erano due sale cinematografiche: fin da piccolo i miei genitori mi portavano al cinema almeno tre volte a settimana e alcuni dei film che ho visto in giovanissima età mi hanno segnato fortemente. L’impulso verso l’attività politica che caratterizzò il ’68 in me durò poco: mi resi presto conto che avrei potuto fare molto di più e meglio mantenendo in primo piano la mia passione per il cinema. Negli anni dal ’68 al ’70 m’inserii attivamente nel movimento studentesco, partecipando alle grandi assemblee generali in Università nuova, ed entrando nel circolo Matija Gubec.
Frequentai anche gruppi politici di area marxista leninista, ma presto mi convinsi che avrei potuto operare in modo più originale e autentico nella ricerca cinematografica: un certo cinema è sempre stato precursore dei tempi e in grado di afferrare la realtà per mezzo delle immagini con una visione capace di andare oltre il quotidiano. Il primato della realtà era limitante rispetto all’universo della creazione estetica. Visto che Lino Micciché, il fondatore del festival di Pesaro, era titolare della cattedra di Cinema all’università, decisi di laureami con lui in Storia del cinema, per poi proseguire il mio percorso in Rai e nel mondo dei festival, che a Trieste nacque anche in conseguenza di quegli anni».
Quali furono i nuovi cineclub che vennero alla luce?
«A metà degli anni ’60 s’interruppe l’esperienza del vecchio Cuc (Centro Universitario Cinematografico), che poi rifondammo negli anni '70, ma alla fine del 1968 Piero e Annamaria Percavassi crearono la Cappella Underground, con un importante apporto di Lorenzo Codelli, che diede un’impronta interessante alla programmazione. Iniziò un lavoro di ricerca che portò a Trieste il cinema d’avanguardia e sperimentale. Oltre alla Cappella, con cui collaborai, ricordo il Circolo popolare del cinema Umberto Barbaro, di area comunista, con cui collaborò da Roma il triestino Gianni Menon, che fu in assoluto il primo a portare a Trieste alcune proiezioni di cinema underground italiano. E ancora il Cineforum Triestino, di matrice cattolica, cui diede un importante contributo Rosella Pisciotta. Dal ’67 collaborai con gran parte dei cineclub del territorio e arrivai al ’68 con la sensazione che nel cinema vi fosse una forte capacità di testimoniare ciò che avveniva nella realtà, pur mantenendo una strada autonoma».
Quanto contò a livello europeo il cinema nel ’68?
«Nel ’68 francese il cinema ebbe un ruolo determinante: le manifestazioni del maggio francese furono rafforzate dalla difesa nei confronti del direttore della Cinémathèque française Henri Langlois, un grande storico e critico cinematografico, estremamente libero nell’approccio alla settima arte. L’allora ministro André Malraux voleva che le attività della cineteca passassero sotto il controllo statale, ma l’intero mondo del cinema francese si oppose all’idea, schierandosi con Langlois. Fu una delle poche battaglie vinte. In molti film francesi del periodo, per esempio in “Baci rubati” di Truffaut o ne “I giovani lupi” di Carné, vi sono riferimenti a questa battaglia e alla figura di Langlois».
E oltre alla Francia?
«Il cinema rende bene il carattere internazionale del movimento sessantottino. Oltre alla cinematografia tedesca e statunitense, anche quella dell’Est Europa fu particolarmente vitale. Dal ’68 al ’72, quando poi vi fu una forte repressione, furono prodotti film particolarmente significativi in tutto il territorio jugoslavo. Alcuni restano tuttora inediti, penso per esempio al film su Goli Otok “Sabbia Santa” (Sveti pesak, 1968) realizzato dal poeta Miroslav Antić, che ho presentato un paio di volte a Trieste: un film durissimo e liberissimo su un tema di cui era vietato parlare. Anche in Unione Sovietica furono realizzati grandi film in quel periodo, in parte rimasti inediti, che dimostrarono ancora una volta come il mondo dell’arte fosse in grado di anticipare i tempi».
E in Italia?
«Una figura fondamentale fu Roberto Rossellini: film come “L’età del ferro” (1965), il primo della sua attività per la tv, in cinque ore offre una visione della storia umana estremamente cupa, che prepara in qualche modo il terreno per il ’68. Come anche Valerio Zurlini, che in “La ragazza con la valigia” (1962) mette in discussione l’intero universo familiare e sociale. Credo che Rossellini e Zurlini siano due cineasti essenziali per capire il ’68, molto più di Bellocchio con “I pugni in tasca” (1965) o di Bertolucci con “Prima della rivoluzione” (1964), che testimoniarono il clima del tempo ma lo collegarono a una dimensione generazionale. Tra i film non italiani del periodo consiglio invece ”Gertrud”, del regista danese Carl Theodor Dreyer, e “Lilith” di Robert Rossen, che danno segni fortissimi sui momenti che porteranno a quel bisogno di liberazione dall’oppressione che fu carattere distintivo del ’68. Non credo che i film di anni recenti siano riusciti a sviluppare una maggior consapevolezza di quel periodo, né a fornire risposte altrettanto rivelatrici».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo