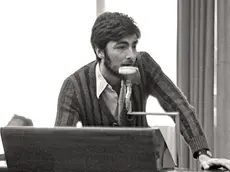Marina Rossi: "Formidabile marzo: portammo il mondo alla Facoltà di Lettere"

TRIESTE Per me l’avanguardia del movimento studentesco, in termini di elaborazione politica, proposte culturali e rivendicative, nacque all’interno della Facoltà di Lettere e Filosofia, occupata dagli studenti nel marzo 1968, due mesi prima del maggio parigino. La facoltà poteva contare allora su un corpo docente di grande spessore, fortemente innovativo. Cito ad esempio Giuseppe Petronio (Letteratura italiana), Giorgio Radetti (Storia della filosofia), Vittorio Mathieu (Filosofia teoretica), Leonardo Ferrero (Letteratura Latina), Filippo Cassola (Storia Romana), Enzo Collotti (Storia contemporanea), Salvatore Francesco Romano (Storia del Risorgimento). Quei docenti ci introducevano in percorsi di ricerca assolutamente inediti, per noi, cresciuti per lo più nell’ambito del crocianesimo, ed avrebbero partecipato alla nostra occupazione, durata 15 giorni, in modo dialettico e costruttivo. In quell’epoca esprimevano quanto di più avanzato potesse esserci nella cultura italiana, non solo nelle aule universitarie.
L’agitazione scoppiata in quella facoltà rientra nella vivacità culturale di Trieste di quegli anni, con i suoi circoli cinematografici: dal Cuc (Centro Universitario Cinematografico) al Barbaro, scoprimmo la Nouvelle Vogue di Godard, il realismo sovietico di Eisenstein, di Dzhiga Vertov, il cinema pacifista di Richardson, di Pabst, di Renoir. Al Teatro Stabile, situato in via Torbandena, ho potuto emozionarmi con il Living Theatre di Julian Beck, con Laura Betti, Paolo Poli, Dario Fo e Franca Rame. Né posso tralasciare l’importante attività del Circolo culturale del Partito Socialista di Unità Proletaria (Psiup), ubicato in Largo Barriera Vecchia: il Morandi promuoveva dibattiti di straordinario interesse, animati da personalità di spicco animate da grandi spinte ideali.
Mi limito a citare Bruno Pincherle, Fausto Monfalcon, Licia Chersovani, Ezio e Livia Martone, Elvio Guagnini, Anna Maria Lumbelli, Fulvio Papucia, Teodoro Sala, Bruna Braida, ma l’elenco non finisce qui. Il circolo attraeva molti giovani orientati a sinistra o aderenti da poco ai partiti di sinistra, incluso il Pci, perché attratti dal livello del dibattito e dalla libertà di pensiero. Tra questi Marina Cattaruzza, Anna Millo, Giorgio Uboni, Dario Mascia, Franco Sala, Marco Braida ed ovviamente chi scrive, insieme a Sergio Ranchi, Fabio e Mario Francescato, Vincenzo Menon. Avrei ritrovato più di uno di questi ragazzi nei gruppi di studio attivati dall’occupazione a Lettere.
Dopo anni di scuola autoritaria, fortemente classista (io provenivo dal Liceo Dante), la statura intellettuale e morale delle persone incontrate al Morandi e in facoltà imprimevano un’accelerazione al mio pensiero, avvicinandomi sempre di più al marxismo, passando attraverso la teologia della rivoluzione con Theilard de Chardin e l’arcivescovo di Recife Helder Camara. Provenendo da quell’esiguo 5% di figli dei ceti disagiati che riuscirono, per merito, ad accedere all’Università, ero convinta come i miei compagni occupanti, a volermi attrezzare culturalmente e politicamente per costruire un mondo più giusto, rivendicando innanzitutto il diritto allo studio e le condizioni materiali per poterlo esercitare. A quell’epoca si partecipava, anche emotivamente, a quanto accadeva nel mondo, eravamo solidali con i popoli in lotta contro il colonialismo e le dittature. Ci appassionava la rivoluzione cubana, ammiravamo figure carismatiche come Fidel Castro, Che Guevara, Camillo Cienfuegos. Furono questi alcuni dei temi dibattuti nei gruppi di studio promossi nella facoltà occupata, ci ponemmo idealmente al fianco di Patrice Lumumba, leader del Movimento di Liberazione in Congo, poi assassinato; a fianco dell’anarchico Grimau, condannato dal dittatore Francesco Franco alla garrota. Ma non trascurammo le lotte dei braccianti italiani a Battipaglia ed Afragola, colpiti, anche a morte, dalla polizia per conquistare una vita più dignitosa.
Tutto ciò che riguardava il mondo riguardava anche noi. I nostri docenti, eredi in massima parte dei valori usciti dalla Resistenza, diedero il loro apporto: Leonardo Ferrero ci ricordò, in un’affollatissima assemblea, i suoi stretti rapporti con Concetto Marchesi negli anni della clandestinità a Padova. Ma furono i contenuti stessi dei corsi monografici a formarci: Gramsci con Giuseppe Petronio, Spinoza e Giordano Bruno con Giorgio Radetti. I docenti di filosofia ci trasmisero i valori della laicità e del libero pensiero, non meno importanti di quello della giustizia sociale.
In quella fase a me, come ad altri giovani, il Pci appariva limitato dal punto di vista del ruolo femminile: frequentando da qualche tempo la cellula universitaria del partito, avevo compreso che per noi ragazze, anche se avessimo voluto entrare nell’apparato, avremmo dovuto occuparci solo di strutture educative e servizi sociali, a dirla in breve di famiglia, asili nido, scuola e sanità. Romantica e sognatrice, pur motivata ad occuparmi di educazione popolare e cultura, ritenevo già allora che le donne dovessero impegnarsi, insieme agli uomini, per dare il loro apporto ai grandi temi in materia di politica nazionale ed internazionale. Paventavo, in futuro, i rischi di una grigia socialdemocrazia che avrebbe spento lo slancio e le speranze che allora ci animavano. Curiosa ed avida di capire, scelsi come modelli di riferimento in materia di emancipazione femminile Aleksandra Kollontaj, teorica del libero amore, e Simone de Beauvoir, che ammiravo immensamente per l’impegno civile, le qualità intellettuali ed il rapporto dialettico con Sartre. Rifiutando il ruolo tradizionale che aveva causato e continuava a causare tanta infelicità alle donne di ogni ceto sociale, mi attraeva il romanzo di Kerouac “On the road”, per quel senso del viaggio e di una frontiera destinata a spostarsi indefinitamente perché intesa come forma di conoscenza multidirezionale, cui intendevo prestar fede.
La nostra occupazione suscitò l’interesse di tutti i partiti democratici, dei sindacati soprattutto della Fiom (sindacato dei metalmeccanici) grazie al legame di solidarietà che il movimento studentesco aveva espresso agli operai dei Cantieri e della Fabbrica Macchine nell’ottobre 1966 a rischio di chiusura con il piano Cipe. Ritornando all’occupazione di marzo, ricordo che, con nostra grande gioia, vedemmo arrivare a Lettere Dario Fo e Franca Rame, sensibili alla nostra vertenza. Si unirono a noi studenti di altre facoltà, aderenti alla sinistra extraparlamentare tra cui il gruppo filocinese diretto da Dario Visintini. Ricordo Piero Panizon, simpatizzante del movimento, allora matricola di filosofia, che si premiò, un giorno, decorandosi da solo con un inedito distintivo cinese a forma di stella che sormontava una pagoda. Nei corridoi di via dell’Università 7, tra un gruppo di studio e l’altro, potevo conoscere meglio i miei compagni di corso. Tra questi Sergio Petrosino, a sua volta studente di Filosofia oltre che membro della squadra politica. In seguito l’avrebbe diretta. Attirò particolarmente la mia attenzione per l’indubbio livello culturale e capacità dialettiche il gruppetto di laureandi formato da Gianni Batticci, Giorgio De Pangher, Dino Sustersich.
In altro contesto Ugo Volli emerse per le non comuni capacità oratorie. Tutto si svolse con grande educazione e senza danni. Ricordo quell’occupazione come una grande presa di coscienza collettiva che allargava un processo di rinnovamento in espansione in Italia, in Europa, collegato agli Stati Uniti. Nel 1970 il mondo della scienza recepiva altre importanti istanze politiche. Per iniziativa della professoressa Licia Chersovani si dava vita ad un coordinamento con i fisici presenti a Trieste nel centro di Miramare per sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi dell’energia nucleare. Si uscì allo scoperto con un presidio al bivio di Miramare. Scintille, speranze presto contrastate da un neofascismo aggressivo a Trieste e altrove: Piazza Fontana, la dittatura dei colonnelli in Grecia… Il cammino della democrazia era irto di ostacoli.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo