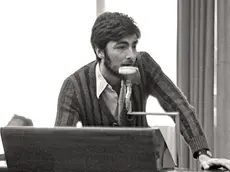Cesare Sartori «A Trieste trovai la passione politica»

TRIESTE “Per farvi un’idea di come iniziò il mio ’68 dovete immaginare un lànfur, termine ironico-spregiativo ancora in voga a Trieste, un brufoloso ragazzotto del contado friulano. Udine allora mi sembrava, e probabilmente era, un luogo periferico e provinciale. Ma avevo avuto la fortuna di studiare al liceo classico Stellini, con uno straordinario professore di filosofia: Gian Giacomo Menon, che mi aveva “contagiato” trasmettendomi la libido sciendi e facendomi intravedere altri mondi, così da aprirmi la mente e lo sguardo”. Cesare Sartori racconta così il suo esordio, nel 1968, a Trieste, dove era giunto dopo il liceo per frequentare l’università. La città giuliana e i suoi abitanti inizialmente erano per lui dei “perfetti sconosciuti” e forse anche questo contribuì a rendere quegli anni un’esperienza irripetibile e indimenticabile, che ebbe conseguenze profonde e durevoli per il suo futuro, tanto da fargli affermare: “Non sarei quello che sono senza quei due anni e mezzo triestini”.
Come visse il trasferimento a Trieste?
«Ero un pandòlo “con il cuore di simboli pieno”, come cantava Guccini in quegli anni, e la testa altrettanto zeppa di confuse velleità, nonché di pregiudizi nei confronti dei cuginastri triestini. Dopo la maturità classica nel luglio ’68 approdai alla facoltà di Filosofia in Città Vecchia. Per molti mesi, soltanto per partito preso e per un infondato pregiudizio anti triestino, la mia vita fu piuttosto solitaria. Invece di mescolarmi con gli “indigeni” me ne andavo solo soletto a mangiare un panino sul molo Audace, se c’era il sole, o in qualche bettola di seconda mano, se pioveva o tirava la bora. Ero un pendolare alla prima esperienza in una nuova città: finita la giornata, senza indugi, prendevo il treno e tornavo nella rassicurante tana friulana, tra i miei pochi ma consolidati e fidati amici del liceo. Ma se fossi andato avanti così dal punto di vista esistenziale per me sarebbe stato un disastro».
Quando arrivò la svolta?
«Gradualmente cominciai a prendere la parola nelle assemblee studentesche di Lettere, a farmi notare. Piano piano intrecciai rapporti e legami, m’inserii nel gruppo e smisi di starmene da solo e in disparte. Imparai a gestirmi la vita, lo studio, le giornate e le notti, e con il tempo cominciai ad apprezzare la città e la compagnia dei vituperati triestini, mescolandomi a loro invece che tornare puntualmente nel rassicurante Friuli. Un evento che considero tuttora importante e decisivo per la mia maturazione fu che venni perfino adocchiato da una delle ragazze più belle e ambite della città. Scelse proprio me, che ero così imbranato e immaturo negli esercizi dell’amore, per non parlare del sesso. E fu una fortuna di cui ancora oggi non mi capacito, perché io non avrei mai avuto il coraggio di fare il primo passo né saputo come farlo».
Si trasformò da pendolare a stanziale?
«Sì, la trasformazione mi fu consentita dal posto ottenuto per merito alla Casa dello studente: all’epoca fungeva da studentato l’hotel Milano di via Ghega e fu in una delle sue sontuose camere moquettate che la sera del 12 dicembre 1969 sbigottito e smarrito ascoltai alla radio la notizia della strage di piazza Fontana. Quell’anno entrai anche a far parte di uno straordinario gruppo di compagni, che presto sarebbero diventati anche amici. Il gruppo ruotava intorno al fortino di via Madonnina, dove aveva sede la Federazione provinciale del Pci: Mauro, Ugo, Piero, Fulvietto, Fabio, Giorgio, Stojan, Giuliana, Giuditta.
Entrai nel gruppo alla pari e a pieno titolo, anche se i compagni continuavano a chiamarmi ironicamente, e ormai affettuosamente, lànfur. Con quel gruppo, guidato da quei “padri politici” che a Trieste furono Antonino Cuffaro e Paolo Sema, demmo vita nel ’70 alla prima sezione universitaria del Pci. In occasione della sua costituzione riuscimmo a far venire a Trieste a tenere conferenze pubbliche dirigenti del calibro di Sergio Garavini, Giuseppe Chiarante, Giovanni Berlinguer e altri. Dopo le conferenze, con o senza l’ospite illustre, finivamo regolarmente da Stelio a mangiare ćevapčići e ražnjići con vino terrano o, quando potevamo fare gli splendidi, la granseola il cui guscio veniva ritualmente sciacquato con l’aspro bianchetto della casa, per bere anche i fruzzòns della polpa».
Come crebbe politicamente?
«In quel turbinoso contesto di fervore e impegno politico ebbi l’onore e l’onere di tenere il mio primo comizio pubblico. Venni spedito, un sabato pomeriggio, nientemeno che nell’affollatissimo viale XX Settembre, che all’epoca era un luogo tabù per i rossi, notoriamente presidiato dai fascisti. A mia protezione ebbi però una scorta d’eccezione: Libero Tribuson e i suoi compagni portuali che, mimetizzati tra la folla variopinta ed elegante della strada, vigilarono con discrezione affinché i neri non mi assalissero per suonarmele. Poi di quell’emozionante pomeriggio ne venni a sapere un’altra: il “terribile” Vittorio Vidali, il leggendario comandante Carlos del Quinto Regimiento, si fece accompagnare in loco da Gabriella Gherbez perché voleva verificare di persona come si comportava quel furlàn di cui tanto gli avevano parlato in Federazione».
Cosa imparò in quegli anni triestini?
«Molte cose che poi mi sono servite tanto nella vita: come si parla in pubblico, come si gestisce un corteo o un’affollata e tumultuosa assemblea, ma anche come ci si destreggia in ristrette riunioni operative. Imparai a inventare slogan e a scrivere documenti politici, appresi come si fanno le ronde notturne antifasciste nonché i turni di vigilanza in una sede di partito. Iniziai a fare le ore piccole assaporando il piacere delle interminabili e il più delle volte inconcludenti conversazioni notturne con gli amici triestini, girovagando per strade e osterie o restandocene chiusi in stanze disordinate o case piene di fumo, delle quali ho ormai perso l’ubicazione topografica ma non il ricordo. E dopo averlo fatto a Udine nell’agenzia Einaudi di Giulio D’Andrea, aprii anche a Trieste un conto libri da Ondina e Gian Luigi, che curavano la distribuzione e la vendita in zona degli Editori Riuniti e di altri editori di sinistra».
E la grammatica dell’amore?
«A differenza dell’andazzo che sembrava generale e in controtendenza rispetto a quanto avveniva intorno a me, curiosamente feci pochissimo esercizio nelle questioni sentimentali o di sesso, imparando quindi poco o niente. Ma fu un problema tutto mio. Naturalmente mi capitò di innamorarmi, venendo all’inizio anche ricambiato.
Ma durò sempre poco: il combinato disposto di immaturità, goffaggine e inesperienza in quel periodo mi fu ogni volta fatale. Ancora oggi, dopo 50 anni, c’è chi mi ricorda che scrivevo belle poesie, ma io non ci misi molto a rendermi conto di quello che si è sempre saputo, e cioè che carmina non dant panem, figuriamoci poi se ti facilitano le conoscenze bibliche. Furono quindi soltanto baci con l’inevitabile, frustrante contorno, ma niente di veramente significativo e conclusivo, se capisce quel che intendo».
Girava droga nel vostro gruppo?
«No, o perlomeno io non ne venni a conoscenza né a contatto. Sicuramente si beveva, in modo conviviale, molto anche se non sempre bene. Ma in questo campo, da buon lànfur, avevO già conseguito “master e dottorato magna cum laude” a Udine, insieme agli amici del liceo».
Come proseguì la sua formazione e maturazione negli anni seguenti?
«Proseguì dal ’71 al ’74 a Udine, come “professionista” della politica (Fgci, Pci, Lega per le autonomie locali, consiglio di amministrazione dell’Atm). Ma questo capitolo della mia vita è un’altra storia. Una vicenda umana che senza l’esperienza di quegli anni triestini, ne sono ancora oggi convinto, sarebbe stata probabilmente diversa. Molto diversa».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo