Tutto Sandro Penna un santo per Pasolini un discepolo per Saba
Esce il “Meridiano”con l’intero corpus delle poesie la produzione in prosa e una gran quantità di inediti
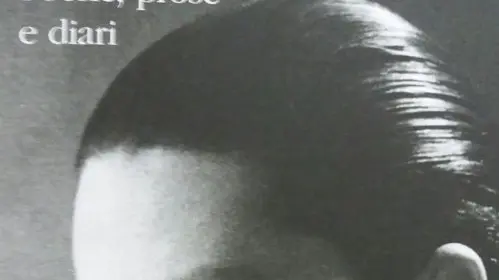
Anche Sandro Penna ha finalmente il suo "Meridiano". Il volume, dal titolo
“Poesie, prose, diari” (a cura di Roberto Deidier
, con una Cronologia di Elio Pecora, pp.
CXLI-1420, euro 80
), raccoglie l'intero corpus delle poesie di Penna, le prose pubblicate in vita dall'autore e una scelta cospicua degli scritti diaristici finora inediti. L'ottima curatela di Deidier consente la lettura avvertita e partecipe di uno dei massimi poeti del Novecento, e stabilisce un nuovo ordinamento delle poesie, sostenuto da un accurato lavoro critico e filologico. Si offre così al lettore un efficace ritratto di "Penna secondo Penna", ricco di testimonianze inedite: tutta l'originalità di un poeta che - ha detto Cesare Garboli - «trascrive direttamente dal vissuto, riducendo a pochi suoni inimitabili una tastiera letteraria fatta di combinazioni miracolose».
Il volume è corposo e ricco di inediti: ci sono alcune poesie ritrovate tra le carte, e altre recuperate da riviste dove Penna le aveva dimenticate; ci sono poi tutti i racconti (quelli di “Un po’ di febbre” e quelli a suo tempo raccolti da Elio Pecora in “Cose comuni e straordinarie”, a cui si aggiungono altri completamente inediti). Una sezione del "Meridiano" è occupata poi dalle note critiche di Penna e dai suoi autoritratti. Infine c’è una selezione pressoché completa dei diari, almeno per quanto riguarda gli aspetti biografici, psicologici e letterari d’interesse.
Professor Deidier, come avete organizzato questo "Meridiano"?
«C’è un vero progetto, a monte, più volte discusso e messo a punto con Renata Colorni, responsabile della collana, e con il suo staff. È un progetto che tiene conto per la prima volta dell’archivio del poeta, delle sue carte, come di quelle conservate in altri luoghi. L’intento è stato quello di avvicinarci il più possibile a un volume organizzato “secondo Penna” e non secondo Pasolini o Garboli, stabilendo dei criteri filologici generali. Un compito difficile, considerato inoltre che Penna si è spesso lamentato delle sue edizioni; si doveva ricostruire un’immagine complessiva dell’opera, in un percorso rischioso, che comprendeva sia le idiosincrasie di Penna che quelle dei suoi interpreti più autorevoli, infine quanto emergeva dalle carte, soprattutto per quanto riguarda la datazione delle poesie. Oggi, seppure con una certa approssimazione, conosciamo le date o il periodo della loro composizione, che cadono per lo più tra gli anni '20 e '40. Negli anni '50 la scrittura di Penna si dirada. Così scopriamo che libri che sembravano appartenere all’ultima stagione, o che erano stati allestiti perché così sembrasse, in realtà contengono testi molto più antichi: qui le responsabilità dei curatori si fanno più gravi, non sono imputabili del tutto al poeta».
Come descriverebbe il ruolo di Penna nella letteratura del Novecento?
«Penna ha dialogato con i grandi padri della modernità, da Leopardi a Keats a Baudelaire. Il loro sogno di una “vita anteriore”, che Penna reinterpreta attraverso la figura del fanciullo, si chiude con lui. Insomma, l’adolescenza diventa in lui simbolo di un’infanzia del mondo, di un’innocenza creaturale. In questo senso il suo è un ruolo di chiusura più che di apertura: il controcanto della poesia nei confronti del moderno termina con i suoi versi, è una parabola che giunge alla fine. Il testimone passa poi alla narrativa: si pensi a Elsa Morante e Anna Maria Ortese, che non a caso amavano molto la poesia di Penna».
Che cosa insegnano oggi la sua figura e la sua produzione?
«Credo che quella di Penna possa essere ancora una grande lezione di rigore. Leggendo i suoi diari si avverte quanto la vocazione estetica sia preservata dall’insorgere delle passioni, dalle loro tempeste effimere. La sua epigrammaticità non è solo una lezione di stile, ma proprio di sintesi e di rigore, direi. Penna, però, proprio laddove sembra un poeta imitabile, è in realtà irraggiungibile. Il suo segreto sta in una certa opacità, in una densità che sfugge alla superficie. Non è il poeta cristallino che in molti hanno rievocato, eppure questo è un punto di forza. Ci costringe a rileggere, se riusciamo a resistere alle sue musiche così perfette e pervasive».
Qual è stato il suo rapporto con Pier Paolo Pasolini?
«Da parte di Pasolini, di adorazione. Lo scrittore friulano ne ha fatto un culto, lo ha definito un santo. Ma ogni altare ha in sé il pericolo di un allontanamento, di una distanza, di una fredda monumentalità. Penna, invece, pur nella sua astrattezza, è un poeta estremamente concreto, i suoi versi pulsano di vita. Vuole essere un poeta prossimo, accostabile, spurio. La sua lingua è lì a testimoniarlo. A Pasolini si deve l’ordine con cui finora abbiamo letto la poesia di Penna, il quale però non era d’accordo, gli rimproverò pubblicamente di sentirsi tradito. Però, alla fine, lasciava fare. Per questo era necessario restituire le poesie alla loro verità documentaria, “smontare” i libri precedenti, sempre curati da editori esterni, e ripristinare quanto Penna avrebbe voluto, almeno per una parte dei suoi versi».
E quello con Umberto Saba?
«Saba fu il primo vero padre letterario. Vent’anni fa pubblicai il loro carteggio (le missive di Penna, purtroppo, erano andate perdute) e le lettere che giungevano da Trieste trasudavano un’umanità e una complicità oggi impensabili. Saba lo incoraggiò, lo fece esordire sull’"Italia letteraria" (la più diffusa rivista di allora), lo soccorse economicamente a più riprese, gli offrì lavoro e gliene procurò a Milano. Fu una figura indispensabile».
Penna venne a Trieste per incontrare Saba...
«Sì. Quando Penna arriva a Trieste, nel settembre del ’37, essendo un bravo ragioniere, aiutò il suo mentore a rimettere in ordine i conti della libreria antiquaria. Lina e Linuccia lo amavano come un figlio e un fratello. Il racconto di quei giorni è in alcune prose di “Un po’ di febbre”. Saba lo introdusse nella cerchia degli scrittori triestini, procurandogli le simpatie di Giotti, Stuparich, Quarantotti Gambini. Come tutti i figli d’arte, Penna peccò di superbia e l’amicizia si incrinò. Sono sicuro, però, e ci sono molti elementi a confermarlo, che l’affetto tra i due non fosse mai venuto meno».
E il Penna prosatore?
«I racconti di Penna sono in strettissimo rapporto con le poesie. Nel mio commento ho cercato il più possibile di dar conto di questa osmosi fra i generi: spesso una poesia illumina una prosa, o trae origine da questa, e viceversa. Alcune poesie di Penna sono nate come prose ritmiche, musicali: il poeta si è limitato solo a separarle in versi. Nelle prose (e nei diari) Penna appare come il tipico flâneur, passeggia per le sue città (Roma, soprattutto, ma anche Milano: le prime ad essere pubblicate apparvero su giornali milanesi, come "L’Ambrosiano"), descrive i luoghi e racconta le sue sensazioni. In tutte, come nelle poesie, vi è la ricerca di quella creaturalità del mondo che per lui rappresenta un assoluto. Insomma non è fiction, non sono prose d’invenzione, ma sono strettamente legate al suo quotidiano».
Che cosa accadrà dopo questo "Meridiano"?
«Spero che questa sia l’occasione per tornare a studiare Penna, attraverso nuove prospettive. La mancanza di nuove edizioni ha comportato un certo diradarsi dell’attenzione critica, negli ultimi anni, sebbene a Penna non siano mai mancati i lettori. So che è in preparazione un numero monografico della rivista "Nuovi Argomenti", con contributi di giovani studiosi. In autunno è previsto un convegno a Perugia, sua città natale. Prenderà avvio una serie di quaderni internazionali interamente dedicati a lui, e intitolati “Il viaggiatore insonne”, che curerò insieme con Raffaele Manica».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo
Leggi anche
Video








