Tinto Brass: «Un erotomane io? Ma se in America mi offrirono di firmare Arancia meccanica»
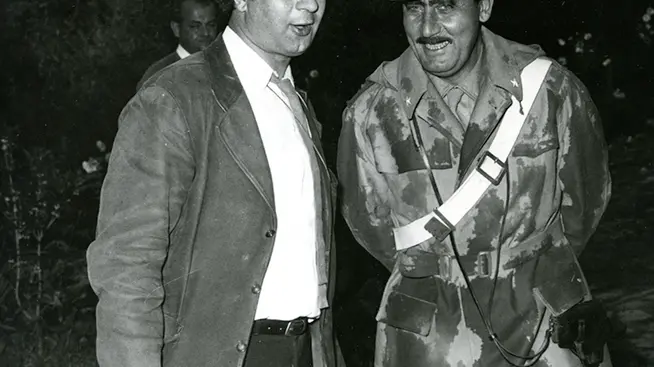
di Paolo Lughi
L’occasione per riconoscere finalmente l’importanza di Tinto Brass nel cinema italiano – dopo decenni di polemiche sulla sua erotomania - è forse arrivata in questi giorni. È stata aperta martedì scorso al Vittoriano di Roma (fino al 23 marzo) la mostra “Tinto Brass: uno sguardo libero”, curata dalla sua compagna e musa attuale Caterina Varzi. Tanti documenti e immagini che testimoniano il ruolo centrale e innovatore avuto in mezzo secolo di carriera da questo “scanzonato pop-artista” (come lo definì Alberto Farassino, per anni docente di Storia del cinema all’Università di Trieste).
Si va dai primi lavori anarchici e sperimentali degli anni ’60 all’esplosione dei sensi (e dei corpi) negli anni ’80, senza dimenticare la sua surrealista visione del mondo, in cui si fondono ricerca formale e analisi sociale.
Brass confessa al telefono che gli ha fatto molto piacere l’attenzione ricevuta all’apertura della mostra.
Si aspettava a 83 anni questa accoglienza da grande autore?
«Ho sempre saputo di essere un bravo regista, sono contento che finalmente l’abbiano capito anche gli altri. Ho ricevuto molti complimenti, grandi manifestazioni di affetto, e ho potuto rivedere anche molte delle mie belle attrici. La mostra è piena di gente, soprattutto di giovani, che possono così conoscere la mia carriera, compresi i primi film».
Come è diventato il ribelle del cinema italiano?
«Andando via giovane da Venezia, città dove sono cresciuto e che mi ha ispirato, ma anche un po’ bandito. Così dopo la laurea in legge mi sono trasferito a Parigi, seguendo la mia passione per il cinema coltivata nei cineclub veneziani. Avevo conosciuto Lotte Eisner che mi introdusse come stagista alla Cinémateque française di Henry Langlois, proprio quando stava sviluppandosi la Nouvelle Vague. Ricordo con simpatia le tantissime proiezioni in cineteca, che proseguivano con lunghissime discussioni al caffè. Ho conosciuto Godard e Truffaut prima che diventassero famosi, il documentarista Joris Ivens che mi ha insegnato tutto sul montaggio e poi Roberto Rossellini, con cui ho collaborato nel 1959 per “India” e “Il generale della Rovere”».
Ma la sua prima regia è in Italia, a Venezia nel 1963, col formidabile “Chi lavora è perduto”, che prefigura i perdenti di Mazzacurati o addirittura “Il grande Lebowski”.
«Sono tornato per raccontare le cose che conoscevo, insieme ad amici come lo sceneggiatore e montatore Kim Arcalli. Il film parla di un giovane che non vuole decidersi a trovare un lavoro, che vagabonda per Venezia immerso nei suoi pensieri. Sperimentai tecniche nuove, riprese nascoste da un carrettino in mezzo ai turisti, la voce fuori campo come un flusso di coscienza, provocazioni visive come una sola scena a colori».
Gli storici del cinema paragonano questo esordio a quelli dei grandi innovatori dell’epoca, Pasolini, Bertolucci, Ferreri.
«Ebbi tanti elogi, ma anche tanti problemi con la censura. Volevo continuare a fare dei film di testa mia e così me ne tornai all’estero, a Londra, dove tutto era più libero e raccontare storie contestatarie era più facile. Lì era andato anche il mio amico Antonioni a girare “Blowup”. Fu il mio periodo più sperimentale, legato alla controcultura, ai nuovi linguaggi del fumetto, della pubblicità, con attori e ambientazioni internazionali».
Il suo film migliore in quegli anni, a suo giudizio?
«”L’urlo” con Gigi Proietti, un grande sperimentatore, e Tina Aumont, che era bellissima e resta la mia attrice preferita. Fu anche il mio film più ostacolato, bloccato dalla censura dal ‘68 al ’74. Ma girai altre opere singolari, surrealiste, come il giallo “Col cuore in gola”, con Jean-Louis Trintignant ed Ewa Aulin, su storyboard di Guido Crepax. E poi “Dropout”, con Vanessa Redgrave e Franco Nero, e “Nerosubianco”, che piacque talmente in America che la Paramount decise di affidarmi la regia di “Arancia meccanica”. Ma io ero impegnato ancora con “L’urlo” e gli americani non aspettarono che lo finissi. Mi dispiacque, ma neanche tanto perché sapevo che non avrei mai potuto girare a modo mio. “Nerosubianco” è anche il mio primo film principalmente erotico».
Come avvenne il suo passaggio definitivo al cinema erotico, con la svolta nel 1983 de “La chiave”?
«Fu ancora una scelta di libertà, una scelta mia che avevo nel cuore, a cui arrivai un po’ alla volta in modo naturale dal ribellismo anni ’60. Volevo parlare dei miei rapporti veri, intimi con la donna che amavo, mia moglie Carla. Come protagonista trovai la Sandrelli, che all’epoca era ancora famosa ma non aveva più una grande popolarità, e il contratto, infatti, non costò molto. Così il suo personaggio fu perfetto per creare scandalo, soprattutto perché interpretò le scene erotiche con grande tranquillità e disponibilità. Mi diede sul set tutto quello che speravo potesse darmi, con tutte le sue grazie come le avevo immaginate».
Perché ha girato “Paprika” a Trieste?
«È una città di mare, entusiasmante per ambientarvi la storia di una prostituta. E poi così ho potuto visitare per un sopralluogo Gorizia, la città di mio nonno, il pittore Italico Brass, da cui ho preso la passione per le immagini e che mi diede il soprannome Tintoretto, da cui Tinto. A proposito di Trieste, alla fine di “Miranda” sul monumento ai caduti ci sono i nomi di Kezich e Cosulich, che mi criticavano sempre. Tullio non la prese bene, invece Callisto accettò lo scherzo».
Nella storia del cinema non sono molti i maestri riconosciuti dell’erotismo. Oltre a lei, Almodóvar, Russ Meyer, Jesús Franco, Catherine Breillat.
«Sono registi che mi piacciono e mi interessano, ma che hanno fatto film diversi dai miei, a cui non mi sono ispirato».
In Italia, dopo Brass, il cinema erotico non ha più sfondato. Si ricordano pochi titoli, “Melissa P.” di Guadagnino, “E la chiamano estate” con la Ferrari, “Tulpa” con la Gerini.
«Sono i produttori che non lo permettono, che non vogliono quelle storie. C’è oggi in Italia una sorta di censura ufficiosa, per cui ormai si fanno sempre più raramente film corrispondenti alle istanze più libere dei registi. Così c’è una grande decadenza non solo nel racconto erotico, ma in generale nel racconto cinematografico».
Vorrebbe ancora realizzare un nuovo film?
«Sì, se me ne danno la possibilità. Ho una storia nel cassetto, si intitola “Ziva, l’isola che non c’è” e racconta di una donna durante la seconda guerra mondiale. Naturalmente non ci sarebbe il ministro Boschi. Quando ho detto giorni fa che vorrei lavorare con lei, era solo una battuta».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo








