Se il maschio si dice sgomento
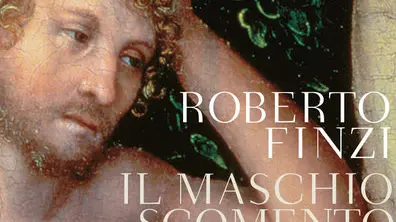
Etimologia di femmina: “fe”, fede e “minus”, meno, per cui «la donna sempre possiede una fede minore». E se per Honoré de Balzac «la donna è una proprietà che si ottiene con un contratto, è un bene mobile», Montesquieu invece accredita nelle “Lettres Persanes” una diceria per cui «le donne russe sospettavano di non essere amate dai mariti se non venivano da loro spesso battute». La donna, prima profanatrice della legge divina con Eva, «porta del diavolo» per Tertulliano, lussuriosa dalla «natura confusa» e «urlante come una scimmia». Che si parli degli «invasati autori» del “Martello delle Streghe”, che aprirà la strada ai due secoli di massacri in gran parte femminili in nome dell'Inquisizione, o di Madame du Châtelet, “collega” di Voltaire che per accedere all'Accademia delle Scienze doveva camuffarsi da uomo, a ripercorrere la questione femminile nei secoli balza fuori una Storia innervata da una misoginia virulenta e senza pari. Una lunga, costante, potente storia di diffamazione che Roberto Finzi, docente di Storia economica, Storia del pensiero e conomico e Storia sociale negli atenei di Bologna, Ferrara e Trieste, affronta nel saggio “Il maschio sgomento. Una postilla sulla questione femminile” (Bompiani, pagg. 336, euro 19) dove prova a dare le risposte, per dirla con l'autore, a «un imponente arcano della storia umana: quello della plurimillenaria subordinazione (e anche schiavitù) delle donne». Il libro sarà presentato al Caffè San Marco il 27 giugno, alle 18.30, dall’autore con lo storico Giacomo Todeschini e Maria Carolina Foi, ordinaria di Letteratura tedesca all’ateneo.
Nel volume si dispiega non solo un'intricata rete di pregiudizi sedimentatisi attraverso i secoli, ma anche di incredibili paradossi. Come il fatto che a essere portatrice di maschilismo è spesso la donna stessa. «Se le donne avessero scritto le storie», titola uno dei capitoli iniziali. In quel caso, fa capire Finzi, la storia sarebbe stata certo assai diversa. Invece, come puntualizza l'autore, nei racconti più autorevoli e celebri a iniziare dai testi sacri, «sempre la donna fu perdizione del genere umano». E con una storia sempre scritta da maschi e dai contenuti rigorosamente al maschile.
Finzi, perché è stata questa narrazione maschile del mondo a prendere il sopravvento?
«La donna pare avere maggiore ardimento intellettuale dell’uomo. E questo sgomenta. Come sgomenta la sessualità femminile. Se, come tutte le storie raccontano, l’uomo ha dalla sua una maggiore forza fisica che gli permette di guerreggiare, accumulare beni, quindi praticare il potere, il simbolo della sua supremazia sta nella virilità. Ma come osserva in una novella di Boccaccio un'anziana a una moglie insoddisfatta “di pel rosso e accesa, la quale due mariti più tosto che uno avrebbe voluti”, che le si rivolge per un consiglio: le donne sono “sempre apparecchiate a ciò, che degli uomini non avviene; e oltre a questo una femina stancherebbe molti uomini, dove molti uomini non possono una femina stancare”. Per rimediarvi non resta che la coercizione della sessualità femminile: con la forza o, dice Adam Smith, con la “più ordinata oppressione della legge”».
Nel suo acuto excursus lungo i secoli emergono profonde contraddizioni. Ce ne evidenzia eclatante?
«Senza dubbio la lunga tradizione culturale di una minore razionalità della donna, quando proprio le azioni per cui la donna avrebbe portato a tutti i mali del mondo implicano l’uso di strumenti razionali forti. Eva agisce usando la facoltà più alta dell’essere umano: il desiderio di sapere. E lo fa servendosi di un altro carattere alto dell’uomo: il libero arbitrio».
Cita il testo recente di un medico per cui il maschilismo «è come l’emofilia, si manifesta nel maschio ma è veicolato dalle donne».
«È un'acuta osservazione di un bel libro di Alfredo Zuppiroli di cui ha avuto modo di parlare tempo fa anche Claudio Magris. Dice una cosa essenziale: la pressione sociale ha fatto per secoli introiettare anche alla donna la fasulla idea della sua inferiorità. Come mai? L’ambiente ma, seguendo Musil, potrebbe trattarsi di un'espressione di quella “prudenza profondamente pessimistica che si trova “nei rapporti di dipendenza dove le forze sono inegualmente distribuite”; cosicché “il più debole trova il suo scampo nel fingersi più stupido di quello che è”, situazione in cui “per il più debole” è “realmente più saggio non passare per saggio”».
Quand'è che la situazione inizia a cambiare?
«In maniera molto schematica, tre fenomeni, tra loro variamente legati, mi pare inneschino il processo di cambiamento: la rivoluzione industriale, la battaglia per l’eguaglianza sociale e politica, la laicizzazione della società. A questo vanno aggiunti eventi eccezionali come le due guerre mondiali per cui, essendo milioni di uomini al fronte, le donne li sostituirono, e benissimo, in funzioni ritenute tipicamente maschili».
A che punto siamo oggi?
«Due dati essenziali sono mutati rispetto alla lunga storia della “questione femminile”: la progressiva eclissi dell’introiezione e quindi accettazione in parte cospicua delle donne della loro supposta inferiorità e lo sgretolamento dello scudo anti-femminile della legge. In questo modo il re è nudo. Gli è indispensabile, inevitabile ridefinire il proprio ruolo. La “questione femminile” si rivela per quello che al fondo è, ed è sempre stata: una “questione maschile”. Il che non significa che i problemi si attenuino o terminino. Anzi. Siamo di fronte allo snodo più difficile. Lo mostra lo tsunami del femminicidio, che è una risposta di debolezza di fronte alle nuove sfide del rapporto uomo-donna. Ma anche per la donna la prova è enorme. Perché la ridefinizione del maschile psichico e sociale comporta di necessità pure una ridefinizione del femminile psichico e sociale».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo








