Ritorna la “Storia di Umberto Saba” la biografia di Mattioni lunga 30 anni
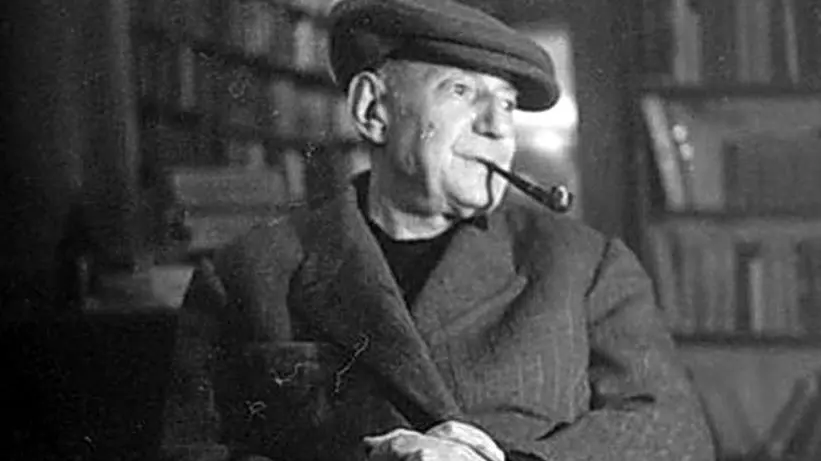
“Questa è una storia e non una biografia, io sono un narratore e non uno studioso”. Con questa premessa, scritta nel 1986, Stelio Mattioni si decideva a pubblicare la sua ‘Storia di Umberto Saba’. In realtà, prima che il libro vedesse le stampe (per Camunia) dovevano passare altri tre anni, un’inezia se paragonata a quando Mattioni aveva iniziato quel lavoro di indagine su Saba. Era il 1959, il poeta era morto da un paio d’anni e Mattioni, allora nemmeno quarantenne e ancora inespresso scrittore, aveva deciso di occuparsi di Saba. Trent’anni, un tempo lunghissimo per tracciare quella che per volontà dell’autore era appunto una storia, cioè il racconto di una vita che, pur partendo da dati reali, assumeva una coloritura personale.
A Mattioni non interessava farsi puntuale biografo; pur avendo frequentato gli archivi, le biblioteche, l’anagrafe, consultato le fonti e incontrato le persone che lo avevano conosciuto, non si voleva porre come un osservatore neutrale. Anzi, sempre nella premessa affermava: “se non venivo a conoscere la sua vita nei fatti reali, mai più sarei riuscito ad aumentare la temperatura del mio interesse nei confronti della sua poesia”. La temperatura, ovvero il calore, la partecipazione, misura di una prossimità ammirata per il poeta ma anche, talvolta, il fastidio per l’uomo. Quell’uomo che aveva la nomea di essere ‘difficile’. E di portare sfortuna.
Mattioni ammetteva che quell’indagine su Saba, concentrata in un paio d’anni tra il 1959 e il 1960, era rimasta nel cassetto della sua scrivania sostanzialmente per scaramanzia. Parlando con la cinquantina di ‘testimoni’ che aveva interrogato, da Giorgio Fano, cugino della moglie Lina, alla figlia Linuccia, a Bianca, il primo amore di Saba, al medico che lo curò alla clinica di Gorizia, Mattioni matura la convinzione che occuparsi di Saba gli avrebbe portato male. “Non sono superstizioso, ma neanche avventuroso”, chiosava.
Poi però, trent’anni dopo, si decideva. E per fortuna, diciamo noi che leggiamo il libro, un libro scritto alla maniera di Mattioni, percorso da una penetrante analisi psicologica nei confronti del poeta e in cui borbotta il dialogo con se stesso, con la propria anima. Libro che prefigurava il suo percorso narrativo e che, esaurito e introvabile, viene ora, (nel centenario della pubblicazione del primo nucleo del Canzoniere) riedito da Vydia (224 pagg., 15 euro) con in copertina un disegno di Ugo Pierri, la prefazione di Riccardo Cepach e l’introduzione di Chiara Mattioni. Entrambi i contribuiti sottolineano come Mattioni fu costretto inaspettatamente a misurarsi con difficoltà di vario genere: dal surplus di dati biografici di Saba che lo stesso poeta aveva fornito, mischiando spesso vero, verosimile e falso, al balletto di reticenze, allusioni, appuntamenti mancati (come quello a proposito del fantomatico figlio segreto del poeta) che contraddistinguono i colloqui con chi, in un modo o nell’altro, era stato in contatto con Saba. Di questi incontri restano i ritratti di ‘Interni con figure’ (Eur, 2011), quasi un dietro le quinte della biografia sabiana, magistrali pennellate che fissano i soggetti (Moravia nella sua casa romana che mentre si rade scruta sospettoso Mattioni) e svelano la vena sulfurea del narratore (l’alito cattivo “che non mi meritavo” di Gianni Bartoli). —
Riproduzione riservata © Il Piccolo








