Monaldi & Sorti: «In coppia riscriviamo le verità dimenticate dagli uomini»
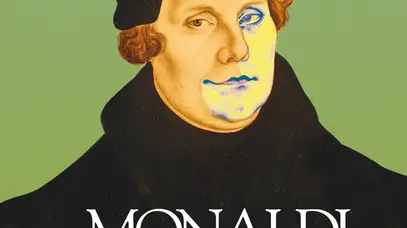
l’intervista
Rita Monaldi e Francesco Sorti compongono un’originale coppia di scrittori. Marito e moglie, vivono a Vienna e hanno pubblicato nove libri, tradotti in 26 lingue e 60 paesi, ma per anni i loro lavori non sono stati pubblicati in Italia. Saranno a Trieste sabato per presentare in anteprima “La riforma di Salaì” (Baldini+Castoldi), il loro ultimo romano che uscirà il 30 ottobre.
Adesso che è finito quel ‘boicottaggio editoriale’, come è stato definito, di cui siete stati vittime, cosa potete dire di quella vicenda?
«Per noi è acqua passata. Come diceva García Lorca, “Chi cammina dimentica, chi resta sogna“. Siamo contenti che i nostri libri siano disponibili anche in Italia, dopo essere arrivati in tanti altri paesi».
I vostri non sono semplici romanzi storici. Ma, come scrivete nell’ultimo libro in uscita fra pochi giorni, ‘La riforma di Salaì’, per voi “la narrativa è la prosecuzione della storia con altri mezzi”. In che senso?
«Il narratore ha tutte le armi di un magistrato, di uno storico, di un leader politico o un sociologo, ma più libertà. Può indagare su un delitto, come fece Sciascia con il caso Moro, senza polizia; può penetrare profondamente un’intera epoca, come Maria Bellonci col Rinascimento, senza cattedra universitaria. Può scongiurare una persecuzione politica, come fece Zola con Dreyfus, senza un seggio in Parlamento. Può perfino profetizzare la società del futuro, come Orwell in 1984. E anche se il Potere occulta le prove, diceva Pasolini, lo scrittore ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia e il mistero».
Salaì è stato il pittore prediletto di Leonardo, si chiamava Gian Giacomo Caprotti. Voi fingete che il manoscritto di Salaì, mai esistito, sia stato ritrovato da uno psichiatra svizzero, il professor Reiter, che è davvero esistito. Cosa vi attrae in questo gioco di specchi tra vero, verosimile e falso?
«Ci affascina – o meglio ci agghiaccia – la perdita collettiva della memoria. Oggi sembra uno scherzo chiamare folle Martin Lutero, che viene ‘riscoperto’ perfino dalla Chiesa cattolica. Invece in passato si è discusso approfonditamente dei gravi disturbi psichici di Lutero, evidenti anche dalle testimonianze dei suoi sostenitori. Non è esagerato dire che con la Riforma la Germania si è consegnata a un pazzo. Accadde del resto anche con Hitler. Non a caso, come ha ben intuito Luciano Canfora, è nelle radici del protestantesimo che si annidano i prodromi del nazismo».
Voi sostenete che la verità è sempre un mistero e l’unica impresa è la dissimulazione. Quale significato dare a questa affermazione?
«Ha due significati. Il primo: di fronte all’inconoscibilità terrena delle verità, l’unica reazione del consorzio umano è far finta di nulla, pubblicando false verità assolute, come quelle scientifiche e razionali, e inducendo il mondo a prenderle per buone, in modo che il mondo dimentichi che le verità assolute non possono essere possedute su questa Terra. Il secondo significato, invece, spiega i nostri intenti letterari: l’unica opera utile, che vada davvero a vantaggio dell‘umanità, è spiegare l’inconoscibilità terrena delle verità, dissimulandone la spiegazione nelle opere d’arte; nel nostro caso, nelle opere letterarie».
Dopo il papa Innocenzo XI con ‘Imprimatur’, ora prendete di mira Lutero. Come mai questo interesse per la religione?
«Esiste forse qualcos’altro? La storia è un perpetuo scontro tra visioni religiose del mondo. Anche fenomeni ‘laici’ come nazismo e comunismo erano animati da sotterranei fremiti esoterici, perché l’anima è perennemente assetata di una dimensione trascendente, anche quando la rinnega».
Avete scritto un finto manoscritto del Cinquecento. Vi siete divertiti a provare quella lingua?
«Tradiremmo il lettore, se non gli facessimo risciacquare i panni nella lingua del periodo di cui legge. Con Salaì ci immergiamo nel romanzo picaresco alla Lazarillo de Tormes, nella farsa medievizzante di Brancaleone contaminata dal latino maccheronico, con un gergo insieme dialettale ed arcaico, strizzando l’occhio agli anticlassicisti del Cinquecento tipo Teofilo Folengo».
Lavorate a quattro mani. Come vi dividete i compiti? Avete mai disaccordi?
«Nessuna divisione di compiti, tutti fanno tutto, come in famiglia con i nostri due figli. All’inizio c’è voluto tempo per armonizzarci, con tanto di discussioni roventi fino alle due del mattino. Sono capitati anche episodi comici, come quando uno di noi due corresse di nascosto un passaggio all’insaputa dell‘altro, subito prima di andare in stampa. Ma dal secondo libro in poi il modus operandi si è perfettamente armonizzato, ognuno dei due scrive sapendo cosa attendersi dall’altro. E quando ha finito una pagina, la passa all’altro per dare la seconda, terza, o quarta mano di “pittura“, e raggiungere un‘osmosi completa in tutto il testo».
Oltre ai libri si prepara anche la tv? Si parla di una fiction sulla vita di Dante con Roberto Benigni.
«Abbiamo in preparazione per la Rai una serie tv su Dante Alighieri e la Divina Commedia, basata su una trilogia di romanzi che stiamo scrivendo in vista del 2021, settimo centenario della morte del poeta. Il progetto è a lunga gittata, parlare di una eventuale partecipazione di Benigni non spetta a noi». —
Riproduzione riservata © Il Piccolo








