L’incoscienza di Svevo: perché lo scrittore non si prese gioco della psicoanalisi
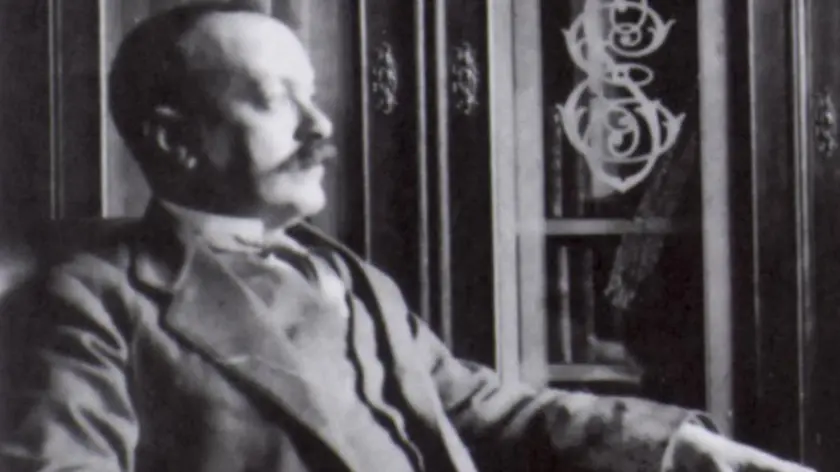
la recensione
Cristina Benussi
Che Italo Svevo si sia misurato con la cultura europea su molti dei temi affrontati nei suoi romanzi è risaputo, così come già abbondantemente indagata è stata la sua onnivora curiosità verso tante discipline, dalla filosofia alla psicanalisi, dalla genetica alla biologia, dalla medicina all' economia, ed altro ancora. Claudio Gigante in “Una coscienza europea. Zeno e la tradizione moderna” ( Carocci , pagg.229, euro 23), rivisita ora molte di quelle suggestioni, mettendo anche contestualmente a confronto gli studiosi che le avevano variamente segnalate e interpretate.
Ne è scaturito un dotto puzzle le cui tessere sono costituite da pagine letterarie ottocentesche, da Balzac a Zola, e novecentesche, da Mann a Joyce, nonché da narrazioni scientifiche e dalle esegesi elaborate a proposito dell'uso che Svevo di quei lacerti aveva fatto. Il corpus è naturalmente relativo ai temi che hanno prodotto la tradizione moderna: la relazione padre-figlio, il rapporto con le diverse tipologie femminili, l'inconscio, il male di vivere, la malattia e la degenerazione borghese, l'inettitudine, la nevrosi, il sogno, la morte. Lo scrittore triestino, accostandosi a umanisti o scienziati, si è però sempre avvalso di una coscienza particolarmente incline a mettersi in discussione per rimodulare continuamente analisi e prospettive, fatte proprie da una ricca galleria di personaggi.
Di qui la varietà, e a volte l'apparente contraddittorietà, delle posizioni su alcuni argomenti, come la psicoanalisi, che ha provocato lunghi dibattiti critici.
Claudio Gigante, attraverso una disamina circostanziata, ha messo però in discussione l'interpretazione diffusa in base alla quale l'autore della Coscienza di Zeno si sarebbe preso gioco della disciplina codificata da Freud, diversamente applicata da altri scienziati e per certi aspetti a loro preesistente. Dimostra che attraverso l’analisi dell’inconscio lo scrittore era ben consapevole di non poter cercare la verità, ben sicuro com'era che non era questa l'altra faccia della medaglia rispetto alle menzogne cui spinge il vivere civile. E invita, per leggere il romanzo sveviano, ad uscire dalla polarità vero/falso, per entrare nel regno del "finto": questo non coincide con nessuno dei due termini ma, come insegnavano già i grandi teorici del Cinquecento, esprime, consapevolmente o meno, una realtà che non è solo quella dei fatti, ma anche dei sentimenti e delle pulsioni. La categoria del "finto", proposta per interpretare i romanzi dello scrittore triestino, rende così molto più chiara la posizione di Zeno che, autoanalizzandosi, non pensa affatto di trovare il" vero" se stesso, quanto piuttosto di cogliere i tanti grumi contraddittori di una coscienza inesorabilmente "creatrice".
Tra romanzi, racconti, epistolari, appunti ed abbozzi, il viaggio dentro la scrittura sveviana fa tappa anche a Trieste, allora culturalmente all'avanguardia, soprattutto per la psicoanalisi: in città la praticava Edoardo Weiss, che dopo l'uscita del romanzo si era offeso con lo scrittore, persuaso com'era di essere lui quel medico sui cui metodi e sulle cui diagnosi Zeno ironizzava.
Un altro concittadino che non ammirava affatto lo scrittore era Giulio Caprin, giornalista che non aveva visto di buon occhio l'improvviso successo letterario dell'industriale di vernici sottomarine. Anzi, pensando di ridimensionalo, lo aveva definito "analista e psicanalista triestino", in contrapposizione all'europeo Proust. Così facendo ne aveva involontariamente colto la grandezza, riconoscendogli di aver operato un «dissolvimento totale della materia narrata (perfino gli analisti devono darsi l'aria di narrare qualche cosa) nella serie infinita dei suoi momenti ».
Amicali erano invece i rapporti con Silvio Benco, con cui Svevo condivideva, tra l'altro, la preoccupazione diffusa in tutta l'Europa per un futuro che si prevedeva catastrofico.
La coscienza di Zeno, come è noto, si chiude con la visione apocalittica di una Terra dove la vita potrebbe essere cancellata, e a questo punto finalmente liberata da tutti i parassiti e le malattie che l'inquinavano. Per Svevo il nuovo discrimine era sancito dal sapere scientifico che, appannaggio di un'oligarchia ristretta, avrebbe avuto il potere di decidere del destino del pianeta.
Ebbene, con tutte le diversità del caso, anche Silvio Benco, nel suo Castello dei desideri, pubblicato nel 1906, non solo aveva affrontato temi vicini a quelli sveviani, come la "debolezza" dei figli rispetto ai padri, la malattia, l'inettitudine; ma aveva anche coltivato l'dea che solo la morte potesse guarire dalla malattia del vivere. Il romanzo, scritto sotto l'influsso del dannunziano Trionfo della morte, aveva destato l'entusiasmo di Svevo, che auspicava per il suo autore un riconoscimento autorevole.
Così non solo ne aveva parlato con sincera ammirazione a Montale, ma aveva anche rimproverato il critico francese Benjamin Crémieux per non averlo citato nel suo panorama di letteratura italiana contemporanea. Come è noto, erano stati proprio loro ad aver portato a fama europea il "creatore" della Coscienza di Zeno. —
Riproduzione riservata © Il Piccolo








