Letizia Schmitz, compratrice compulsiva dei libri “circolanti” del Gabinetto Vieusseux
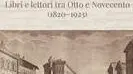
TRIESTE Si era abbonata alla “Biblioteca circolante” di via dei Vecchietti il 7 gennaio del 1918, a ventun anni, poco prima che nascessero i suoi tre figli: Piero, Paolo e Sergio, i primi due dispersi sul fronte russo, il terzo caduto il 1° maggio 1945 durante la liberazione di Trieste. Letizia Schmitz non era una ragazza qualunque. Nata nel 1897 da Ettore Schmitz e Livia Veneziani, aveva respirato in casa letteratura mitteleuropea e i primi studi di psicanalisi. È nel 1918 che suo padre, Italo Svevo, impiegato nella ditta di vernici del nonno, ma già autore di due libri pubblicati senza successo, Una vita (1892) e Senilità (1898), aiuta un cugino medico a tradurre Die Traumdeutung di Freud. L’anno dopo avrebbe iniziato a scrivere La coscienza di Zeno.
Allo scoppio della guerra, Letizia viene mandata a Firenze, ed è lì che si iscrive al Gabinetto dei Vieusseux: «Si trattava allora di una grande e ben fornita biblioteca circolante, della quale divenni assidua cliente: e la strada che conduceva dal mio albergo in via dei Vecchietti divenne per me un percorso abituale». Lo racconta nel 1979, in occasione delle celebrazioni svolte allo stesso Vieusseux per ricordare il cinquantenario della scomparsa di Svevo, morto per i postumi di un incidente d’auto nel 1929, a pochi anni dallo scoppio del “caso Svevo” sulle colonne della “NRF” e dell’”Esame”, dove Montale, nel 1925, ne avrebbe decretato il successo.
Nel 1918 il Vieusseux aveva quasi un secolo di vita. Lo racconta ora, festeggiandone i duecento anni dalla nascita, il catalogo della mostra, allestita all’Archivio Contemporaneo A. Bonsanti, e curata da Laura Desideri, che per più di trent’anni si è dedicata alla Biblioteca Storica dell’istituzione, accompagnata da una serie di iniziative culturali, tra cui il ciclo Le parole del Vieusseux, iniziato lo scorso novembre e che proseguirà fino ad aprile 2021 in streaming nella sala virtuale del Cinema La Compagnia (il programma nel sito del Vieusseux: www.vieusseux.it).
Era stato fondato nel 1820 dal quarantenne Giovan Pietro Vieusseux, nato a Oneglia da una famiglia ginevrina, giunto a Firenze dopo vent’anni di viaggi commerciali che gli avevano fatto attraversare tutta l’Europa, dalla Francia al Belgio, la Danimarca, l’Olanda, la Svizzera, la Norvegia, la Finlandia, la Russia, fino ad Odessa, Costantinopoli e la Grecia (scrive nel 1824: «poco avevo letto, ma visto e osservato di molto»). Uomo di relazioni più che di studi, ma con un «forte senso della cultura e della circolazione delle idee, del progresso scientifico ed economico» (p. 20), fortemente legato all’economista ginevrino Simonde de Sismondi (uno degli ideologi i cui studi storici ed economici sarebbero stati centrali nella formazione di Manzoni), decide di impiantare a Firenze uno “stabilimento” destinato alla lettura.
Dal 1827, ogni lunedì, serate con ospiti illustri: primo invitato: Alessandro Manzoni, giunto a Firenze il 3 settembre, dopo un rocambolesco viaggio con Enrichetta, Giulia (Beccaria) e i sei figli, con i Promessi sposi freschi di stampa (che scoprirà di dovere riscrivere da capo…). Accolto da Vieusseux, e dai migliori intellettuali del tempo, da Niccolini a Giordani, appare subito di “animo gentile” e “alto ingegno”. «Peccato - scrive Mario Pieri, presente alla serata - che sia invaso dalla romanticomania». Seduto in un angolo, silenzioso, il ventottenne Conte Leopardi, da due mesi arrivato a Firenze, che quattro anni dopo avrebbe dedicato “agli amici suoi di Toscana”, l’edizione dei Canti. Palazzo Buondelmonti (il Gabinetto sarà poi trasferito in via dei Vecchietti, in un palazzo costruito ad hoc), diventerà luogo di incontri, letture di giornali, e anche centro di diffusione di nuove e internazionali letture. Insieme ai giornali, infatti, Vieusseux allestisce anche una biblioteca circolante: un servizio, diremmo ora di “document delivery”, di prestito a domicilio, calcolato sulla base della durata del prestito e sul numero di libri. Un Amazon ante litteram, che formerà generazioni di scrittori, soprattutto nel primo novecento: da Palazzeschi a Papini e Prezzolini, da Renato Serra al giovanissimo Alberto Moravia, che a quattordici anni prende in prestito la traduzione francese dei Fratelli Karamazov, e rinnoverà l’abbonamento per ricevere in spedizione i libri – di nuovo Dostoevskji: Humiliés et offensés – nel sanatorio di Cortina D’Ampezzo.
Tornata a Firenze, cinquant’anni dopo la breve parentesi fiorentina, Letizia avrebbe ricordato con commozione quel centro di cultura e incontri internazionali, che, come Trieste – crocevia naturale di lingue e intelletti – era stato il Gabinetto Vieusseux, offrendo un luogo di ritrovo, lo stimolo della lettura quotidiana dei giornali nazionali e internazionali, quell’humus in cui avevano trovato terreno fertile le idee di un secolo davvero nuovo, proseguito in tutto il Novecento e fino ad ora – unico Gabinetto di Lettura in tutta Europa - che festeggia con questo splendido catalogo i suoi (primi) duecento anni: «Non posso descrivere la mia meraviglia nel vedere il cambiamento radicale del Gabinetto Vieusseux, nel mio ricordo biblioteca circolante ed ora diventato un grande centro culturale: e questa cultura esso non la tiene gelosamente per sé ma la irradia nel mondo». —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo








