Le gallerie d’arte sono scomparse con i collezionisti
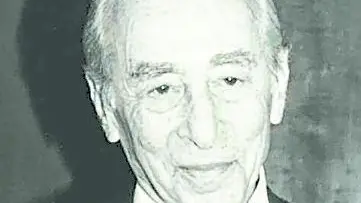
Trieste città dell’arte. Nella storia artistica della città sono molti i nomi di spicco, da Veruda a Nathan a Bolaffio fino a Chersicla e Spacal, nell’arco di almeno 150 anni. Basta visitare le sale del Museo Revoltella, una tra le maggiori pinacoteche del nord-est, per accedere a un campionario rilevante di artisti che in molti ci invidiano. Un settore culturale, questo, in cui la città ha primeggiato in passato, specie se si fa riferimento alle gallerie d’arte, che, specie negli anni settanta e ottanta del secolo scorso, hanno gestito la divulgazione della pittura, aprendosi al mondo esterno e fornendo spesso una finestra sulle nuove correnti contemporanee. A dare un’occhiata al mondo delle gallerie d’arte nel periodo fra gli anni Sessanta e la fine del Novecento emerge un articolato panorama di offerte, spesso molto qualificate, che accomunava centri come la Tor Bandena, la Tommaseo, la Cartesius, lo studio Bassanese, il Planetario, fino alla Galleria Lipanje Puntin. In quegli anni, anche come retaggio degli influssi e degli stimoli delle Biennali veneziane, sempre molto sentite a Trieste, esisteva in città un tessuto culturale legato alla pittura (e alla scultura, basti pensare a Mascherini) che guardava alla tradizione certo, ma che era assai permeabile ai nuovi indirizzi (citiamo, fra le altre, la predisposizione per l’arte astratta della galleria Tor Bandena, o quella dello Studio Bassanese) e agli stimoli europei e americani (tra cui la presenza, anche se solo saltuaria, di Leo Castelli, come ricorda Nadia Bassanese). Una vivacità intellettuale molto costruttiva, si potrebbe dire, alimentava un dibattito interno al mondo dell’arte, che trovava riscontro sulla stampa e che, più che altro, stimolava il collezionismo locale, assai presente a Trieste: un serbatoio di domande legate anche a una disponibilità finanziaria adeguata. Non voglio qui affermare che vi fosse, in passato, una vasta presenza di pubblico, ma prevaleva la volontà di fare, di conoscere, di introdurre nuove proposte artistiche. Trieste come parte terminale di un mercato italiano complesso, pur sempre “bloccato” dal confine jugoslavo, ma vivo e legato alla creatività e intraprendenza di personaggi come Anita Pittoni o Miela Reina.
Insomma le idee circolavano e gli appassionati avevano molte occasioni di accedere alle proposte di acquisto, filtrate dalle scelte dei galleristi. E le gallerie stesse avevano la medesima funzione delle librerie, entrambi luoghi dove si andavano a vedere cose nuove e dove, oltre a condividere amicizie, si discuteva di movimenti e di indirizzi. A farla da padrona, certo, era la medio-alta borghesia, che aveva in tasca il necessario per gli acquisti, e che era stimolata ad accedere, per esempio, alle nuove linee dell’astrattismo, quando, per fare un esempio qualificante, alla galleria Tor Bandena erano in mostra artisti come Fontana, Manzoni, Bonalumi, Turcato, Vedova, Hartung, Santomaso. Ma va anche aggiunto che, sul mercato, vi erano molti altri artisti, ora rarissimi, e molto più facile accedere a Piero Marussig, a Afro o a Music o a Guttuso, che venne a Trieste per incontrare gli appassionati d’arte. E ciò perché allora il mercato era forse più accessibile. Per esempio, come ricorda Alessandro Rosato della Tor Bandena, «negli anni ’70-‘80 si trovavano opere d’arte di alto livello anche per due/tre milioni; cosa non più possibile». Ma ora, negli anni dieci del XXI secolo, tutto questo patrimonio pare smantellato. Delle tante gallerie (qui ne ho citate solo alcune) non ne resta più nessuna (Torbandena, Lux Art, Rettori Tribbio), ed è scomparsa quella rete virtuosa che sapeva attrarre, oltre ai collezionisti, anche gli artisti. Resta sicuramente il ruolo che svolge la casa d’aste Stadion, le cui vendite sono ottimali: sia sul piano del recupero di opere di pregio tra il collezionismo locale, disperso dopo la morte dei proprietari, sia per la sua funzione di vetrina dell’Impressionismo sloveno. Pure, tutto ciò non muta l’idea di un bilancio fallimentare di fronte alla dovizia di un tempo, il che rientra in un più ampio discorso sulla linitatezza di molte iniziative culturali nella Trieste di oggi. Infine, non va sottaciuta la mancanza di collegamento tra le gallerie e le istituzioni pubbliche. Che raramente “fanno sistema”. Un esempio da ripetere, che guardi al futuro, è sicuramente quello della mostra Controcanti, che si tenne al Revoltella nel 2016: frutto di una buona collaborazione fra Torbandena e Museo, volta a valorizzare una lettura pubblica e privata degli artisti d’oro degli anni ‘50 e ’60. Si discute sempre dell’efficacia di Grandi Mostre a Trieste (basti pensare a quelle “illyane” di Basquiat, Rosenquist, Jim Dine degli anni ’80 la cui risonanza, peraltro, non andò oltre Venezia). E forse una rinascita di questo settore potrebbe partire dalla reimpostazione di una reale politica di collaborazione fra istituzioni e iniziative private.
Riproduzione riservata © Il Piccolo








