La Repubblica di Weimar un’analisi che aiuta a capire le contraddizioni dell’oggi
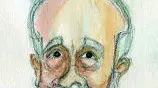
Studiare la crisi della repubblica democratica di Weimar, nella Germania inquieta tra la sconfitta delle Prima Guerra Mondiale e il precipizio negli orrori nel nazismo, nel primi anni Trenta. E, riflettendo sulle pagine di storia, cercare di capire quali lezioni d’attualità ricavarne. “Sindrome 1933”, scrive Sigmund Ginzberg, giornalista con una robusta cultura storica (Feltrinelli, pagg. 192, euro 16). Evitando di esasperare le facili analogie con il presente (il richiamo ossessivo al “popolo”, le polemiche contro la libertà di stampa, il gioco sulla leva di paure e rancori per i “diversi”, il nazionalismo spinto, la gestione demagogica delle finanze pubbliche gonfiando il debito) Ginzberg ricostruisce le ragioni del credito affidato dai cittadini tedeschi a Hitler e va oltre la spiegazione dell’indubbia abilità nella propaganda: “I nazisti toccavano tasti cui la gente era sensibile, blandivano interessi reali e diffusi (non solo quelli del grande capitale). A elargizioni concrete corrispondeva consenso reale, crescente e formidabile. La cosa che più impressiona è come siano riusciti a trovare consenso anche sui comportamenti più atroci e disumani del regime”.
“Utopia e tragedia”, è il sottotitolo di “La Germania di Weimar” di Eric D. Weitz, storico al City College di New York, per Einaudi (pagg. 536, euro 28). “L’utopia” sta nell’impegno per la ripresa dopo la guerra, in un clima di ristabilimento delle condizioni democratiche e di straordinario fermento culturale e sociale. Si avvia un’incisiva riforma del welfare, per rispondere al disagio delle classi popolari. E si vive una frenetica sperimentazione di nuove tendenze intellettuali, che riguardano l’architettura (il Bauhaus) e la filosofia, la fotografia e il cinema, la letteratura e la musica. Ma le radici della democrazia sono fragili. L’economia va malissimo. E alla fine - ecco “la tragedia” - tutto precipita nell’illusione dell’ordine e nella retorica dell’uomo forte.
“Morte della democrazia”, è il titolo del saggio di Benjamin Cartel Hett, storico alla City University di New York (Einaudi, pagg. 344, euro 30) per raccontare “l’ascesa di Hitler e il crollo della Repubblica di Weimar”. “Libro dell’anno” per “The Times”, l’opera di Hett analizza l’illusione dei politici conservatori di governare e addomesticare il nazismo, la pesantezza delle tensioni sociali prive di risposte capaci d’affrontare un crescente impoverimento di larghi strati sociali, l’illusione della scorciatoia autoritaria che travolge la democrazia e fa precipitare la Germania “in una feroce dittatura”. Tutto comincia con l’incendio del Reichstag, la notte di lunedì 27 febbraio 1933. Hitler è al potere, come cancelliere, da appena quattro settimane. “Terrore bolscevico”, proclama, indicando i colpevoli dell’incendio nei comunisti e negli avversari del partito nazista. Incendio appiccato “da sgherri assoldati dal governo di Hitler”, scrive invece l’autorevole “Wiener Allgemeine Zeitung”. Parte la repressione. Crollano anche gli ultimi fragili baluardi della repubblica democratica.
Riparlare di Weimar significa anche riflettere sulle necessarie iniziative per affrontare la crisi attuale della democrazia liberale. Cominciando dall’attenzione verso bisogni e speranze delle nuove generazioni. Proprio da una serie di incontri con i ragazzi del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Maglie (Lecce), nasce un libro di grande interesse, per temi discussi e per chiarezza di linguaggio: “Le sfide della democrazia. La paura e la lusinga” (Laterza, pagg. 299, euro 18) a cura di Annarita Corrado, Mariano Longo, Rosario Tornesello e Alberto Vannucci. Il saggio introduttivo è di Sabino Cassese. Tra i contributi, quelli di Giovanni Maria Flick sull’attualità della Costituzione, Salvatore Veca sul rapporto tra libertà e giustizia, Raffaele Cantone sulla necessità di resistere alle insidie della corruzione e di Giancarlo Caselli, Umberto Ambrosoli e Armando Spataro sulla lotta contro terrorismo e mafia. Lezioni civili, nel dialogo con gli studenti. Per confermare che la democrazia ha una straordinaria attualità. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo








