La nave nel molo Audace
Nessuno riuscì più a riportare a galla il vascello San Carlo affondato davanti al Mandracchio con tutte le attrezzature
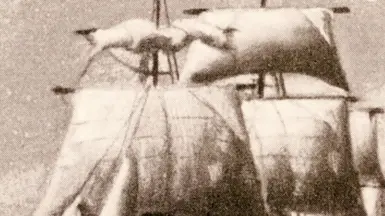
Il vascello da 70 cannoni San Carlo, oggi tombato sotto il molo Audace, divenuto inutile iniziò a venir sommerso artificialmente. “All’inizio di ottobre del 1737 – spiega lo storico Paolo Marz ripetendo quanto riporta nel suo saggio “Da Carlo VI a Maria Teresa. La costruzione del porto di Trieste e la nascita della Marina dei Paesi ereditari austriaci” - la Marina aveva cominciato con l’affondare, su un fondale di dieci passi, in un punto vicino alla bocca del mandracchio (ad una sessantina di metri dalla riva), il vascello San Carlo con tutta la zavorra e molti materiali appartenenti al munizionamento e alle attrezzature di bordo. «Ma ben presto – continua lo storico triestino - si dovette constatare che la presenza del relitto comprometteva l’accessibilità del mandracchio e l’utilizzo dell’arsenale cesareo. Essa, infatti, rendeva difficili e pericolose, in certe condizioni di mare e di vento, l’entrata e l’uscita dal piccolo porto interno e, contemporaneamente, sottraeva all’arsenale una decina di metri all’estremità sinistra del fronte a mare dello squero, il cui sviluppo complessivo era di settantacinque metri circa».
Il bibliotecario Stelio Zoratto, che ha ricostruito la storia del vascello costruito come si è visto in Inghilterra e varato come Hms Cumberland nel 1695, ha recuperato i resoconti cronachistici dell’episodio riportati anche a un secolo di distanza. Si legge infatti sul periodico “L’Istria” dell’11 novembre 1848: “Fu provato a liberarlo dall’acqua, ma l’operazione non riusciva; nei dì 27 e 28 aprile 1738 vi applicarono molte trombe assorbenti, 100 e più uomini vi lavorarono per sei giorni, però inutilmente, tanta acqua veniva levata, tanta entrava. In marzo 1740 venne ordine di disfarla e vi si diè mano nel maggio seguente, ma il più della nave era sott’acqua, pur si volevano ricuperare il corpo, tutti i cannoni e le molte palle che vi erano; applicarono allora due ruote per estrarre l’acqua, molte trombe e vi impiegarono 400 persone, ciò avveniva sulla fine di giugno. Alla metà di luglio si fe’ altro esperimento, tutto inutilmente. In sul principio di settembre si tornò all’impresa, colle due ruote, con 19 trombe e con 600 persone; fu fatica e danari gettati, e si abbandonò l’impresa: il San Carlo affondò sempre più nella fanghiglia nel 1740”. Testimonianze dirette si trovano nei diari di Antonio Scussa che ad esempio nei primi giorni del settembre 1740 annota: “Di rinovo nella nave di San Carlo hanno fatto prova di secare l’acqua che v’è entro con trombe n° 19 e 2 rotte (ruote,
ndr
) che bene lavorano e 600 uomini pagati a L. 2 per uno, ma indarno fu la strusia e spesa, hanno dovuto lasciare il tutto come prima, e ciò fu il 5 sudetto”.
Il decreto aulico del 6 maggio 1752 accoglie la proposta del presidente dell’Intendenza, conte Hamilton, di rinunciare ad ulteriori tentativi di ricupero del relitto del vascello San Carlo e di impiegarlo, invece, come nucleo del costruendo ‘contro-molo’, a difesa dai venti da Nord e da Est. È l’atto di nascita di quello che, per tutto il tempo dell’appartenenza di Trieste alla Monarchia austriaca, sarebbe stato il Molo San Carlo. “Nei mesi di novembre e dicembre del 1756 – narrano cronache successive - si spesero per il molo 5.400 lire di quel tempo. Napoletani, rovignesi, triestini vi condussero con le loro barche pozzolana, pietre, sabbia, scagliame di pietra, ghiaia. Le pietre vennero estratte dalla cava di San Pietro a Roiano”. “Nel 1762 – rileva Marz - la lunghezza del molo era di 40 Klafter (m 76 circa), alla quale si aggiungeva quella della scogliera (29 Klafter, pari a 55 metri)”. Ancora nelle cronache: “Un rafforzamento ebbe il molo nel 1771. Vi furono impiegate 800 migliara (tonnellate,
ndr
) di pietre grosse per formarvi una scogliera frangionde. Nel 1778 il molo venne prolungato di metri 19. Tra il 1860 e il 1861 vi fu interrata la scogliera che stava alla testata e tolto il ponte levatoio che fino dall’origine univa il molo alla terra. In quegli anni esso ebbe il suo definitivo prolungamento che fu di metri 132,70 raggiungendo per tal modo metri 246,50 di lunghezza e 25 di larghezza. Nel 1905 però il molo perdette circa 20 metri di lunghezza causa l’allargamento in fuori delle rive”. E sull’Istria del 1848 si legge che “Il molo divenne ben presto il luogo prediletto di passeggio; ed era costume delle signore dopo fatto il giro della piazza e passeggiato sotto i portici del palazzo pubblico di uscire per la porta del mandracchio e di andare a prendere i freschi sul molo che era sparso di ghiaia fina”.
Dal molo San Carlo nel 1818 partì il Carolina, la prima nave a vapore che univa Trieste a Venezia, dopo due decenni vi ormeggiavano i primi piroscafi del Lloyd Austriaco. “Un fatto che non si può dimenticare – ha scritto una ventina d’anni fa il cultore di storia locale Edoardo Marini – fu quello successo una sera d’agosto del 1812. Quando il pubblico a passeggio si dissetava con le aranciate granite a 15 soldi il goto tra i vari caffè volanti ebbe a un tratto l’impressione di una terribile scossa tellurica: la Danae, una fregata francese ancorata dirimpetto al molo, era saltata in aria. Le lastre delle finestre delle case più vicine al porto andarono in frantumi e le porte si spalancarono per lo spostamento d’aria provocato dall’esplosione. Ad Opicina i quadri dentro la chiesa si staccarono dalle pareti. Un pezzo della fregata era andato a finire sul tetto del teatro. Tutto l’equipaggio di 350 uomini vi trovò la morte e le vittime si pescarono fin nelle acque di Barcola”.
(3 - Continua)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo
Leggi anche
Video








