«Io & Anna Karenina Così ho svecchiato l’eroina di Tolstoj»
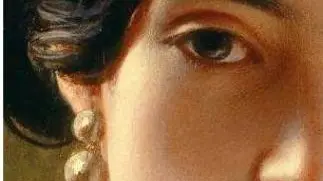
di FEDERICA MANZON
«L'editoria ha un ruolo culturale. Non possiamo permetterci di vedere i classici ammuffire nei cataloghi delle case editrici. Dobbiamo riportarli in vita. È un obbligo verso il lettore».
Gioiamo di questa dichiarazione di Enrico Gianni, traduttore e curatore della collana Grandi Traduzioni di Einaudi. Un progetto coraggioso quello della casa editrice torinese, in un'epoca in cui si parla di libri solo per litigare su quale sia il salone buono dell'editoria, e nelle vette delle classifiche dominano l'erotismo poco erotico o i gialli psicologici con una psicologia alla Donald Trump. Einaudi rilancia i classici con nuove traduzioni pubblicandoli nella prestigiosa collana dei Super Coralli. Costano troppo? Prendiamo “Anna Karenina” (trad. Claudia Zonghetti, 968 pp.) 28 euro. Troppo? Aspettate. L'editoria non è un lavoro no-profit e i conti devono quadrare. Perché una traduzione sia “affrontabile” economicamente in una pubblicazione tascabile il traduttore viene pagato dai 5 agli 8 euro a pagina. Prendiamo un libro come Karenina: un traduttore velocissimo traduce al massimo 30 pagine al mese, il che vuol dire due anni e mezzo circa. I conti sono presto fatti: uno stipendio che assomiglia alla paghetta degli adolescenti di buona famiglia. E allora, quando entrate in libreria a comprare la nuova traduzione di Dostoevskij o Stendhal, prima di storcere il naso al prezzo di copertina ricordatevi che quel prezzo permette al traduttore uno minimo sostentamento, permette a voi di avere una traduzione di qualità, e se non potete affrontarlo, dopo pochi mesi arriverà comunque l'edizione tascabile.
Ma perché ritradurre i classici?
«Le traduzioni che abbiamo risalgono spesso agli anni Trenta» spiega Enrico Gianni. «A quei tempi si usava un italiano da vestito buono, ma nel frattempo la linguasi è trasformata e anche la critica ha cambiato il modo di leggere i romanzi».
Leggiamo romanzi nuovi rispetto a come li conoscevamo?
«Un esempio: Moby Dick è pieno di riferimenti all'omosessualità che nelle vecchie traduzioni sono sfuggiti, interi giochi di parole attorno al rapporto tra Ishmael e Queequeg erano rimasti nello sfondo e invece Ottavio Fatica gli ha ridato voce».
Romanzi tradotti da traduttori e non da scrittori, una scelta precisa?
«Sì, credo che per tradurre i capisaldi della nostra cultura sia necessario qualcuno con un'esperienza molto solida e senza rischi di sovrapposizioni. Prendiamo Pavese con "Moby Dick": era giovanissimo e quella traduzione era per lui uno strumento per arrivare al proprio linguaggio attraverso gli scrittori americani. È una cosa interessante, ma non il nostro progetto».
È appena uscita la nuova traduzione di Anna Karenina, la parola alla traduttrice...
«Tradurre Tolstoj è stata per me una sfida. Volevo risoffiare un po' di vita nelle pagine, non nel senso di aggiungerne, ma provare a restituire quella che c'era ed era rimasta soffocata nei corsetti stretti dell'italiano forbito di una volta» dice Claudia Zonghetti, con l'entusiasmo di chi con il capolavoro russo ha trascorso notti e giorni simbiotiche. «Ho cercato di ridare un po' di colore e precisione alle parole. Soffrivo ogni volta che vedevo qualcuno leggere Anna Karenina e dire “sì, però, che noia”. Era un best-seller dei suoi tempi! Un romanzo intrigante, pieno di vita».
Perché leggere la nuova traduzione di Anna Karenina?
«Perché il lettore deve godersela. È un romanzo ipercontemporaneo, fatto di sotterfugi, sogni zozzi, seduzioni eccitanti e sensi di colpa, pettegolezzi pissi pissi, tormenti di gelosia pazza, occhiate, inquietudini. Se cambi i vestiti e i balli, ti accorgi che i meccanismi e le reazioni, perfino certe risposte sono davvero immortali. È questo ciò che definisce un classico, no?».
Aveva paura nel momento in cui ha accettato l'impresa?
«Paura c'era ed era grossa. Ma è stata una rivelazione. Traducendo leggi davvero. È come pregare. Riesci a leggere ogni piega, a vedere la polvere sotto i tappeti. Leggi con lentezza, scopri i trucchi dell'autore».
I trucchi di Tolstoj?
«Lessicalmente ad esempio Anna cambia tantissimo. Alla sua comparsa è posata, sa sempre qual è la cosa giusta da dire in ogni occasione. Da grandissima dama del bel mondo è calma, misurata. Poi mano a mano che cede alle passioni, a Vronskij, le stesse frasi si fanno spezzate, sincopate, diventano singhiozzi, isterismi. Una maestria assoluta. Così come Tolstoj è maestro nel rendere le elucubrazioni in burocratese puro di Karenin. Scena bellissima è quella in cui lui torna a casa da solo, mentre Anna è rimasta al ballo con Vronskij. Karenin sa che gli altri hanno notato i sentimenti di Anna e si prepara a rimproverarla, a farle presente che il suo comportamento non sta bene. Quelle due pagine del suo andirivieni tra le stanze della casa in cui a ogni stanza corrisponde una fase del suo pensiero che continua ad attorcigliarsi su se stesso e a ripetersi è un magistrale flusso di coscienza, mezzo secolo in anticipo».
"Le famiglie felici si somigliano tutte, le famiglie infelici lo sono ognuna a suo modo" una traduzione nuova del famoso incipit che ha suscitato qualche polemica...
«Ho tradotto l'incipit così come l'ho sentito, assertivo e non ridondante. Ma ci ho pensato a lungo, per convincermi che non ci fosse il minimo intento di “farlo diverso” apposta. Quella ripetizione “ogni famiglia infelice è infelice a modo suo” nell'originale non è una ripetizione. Il russo può dirlo solo in quel modo, con la ripetizione dell'aggettivo, non avendo la forma pronominale. Il secondo “infelici” che io ometto è poi nella forma breve, non è nemmeno una ripetizione cadenzata. L'italiano apre a diverse varianti e ho scelto quella che sentivo più calzante. Mi ha colpito che l'unico traduttore madrelingua russo, Ossip Felyne, usi un sinonimo “ogni famiglia infelice è disgraziata a modo suo”, senza i bisogno di tradurre una ripetizione che evidentemente all'orecchio russo non c'è».
La sua traduzione trasforma il ritmo rispetto a quelle a cui siamo abituati...
«Per me è stato decisivo l'ascolto dell'audiolibro. Le frasi lunghe e costruite in ogni dettaglio architettonico, che all'orecchio di un non russo possono suonare ostiche, ascoltate emergono in tutta la loro fluidità e meraviglia formidabile. Non a caso Bulgakov e Vasilij Grossman dicevano “non c'è una frase in Tolstoj che non funziona”. Ripetizioni ce ne sono, ma semmai servono alla caratterizzazione dei personaggi, nei loro tic, nel modo di parlare tipico delle diverse classi sociali».
Che ne è quindi della "noia di Tolstoj"?
«La noia semmai è data dai discorsi non dallo stile. Quando la mattina mi alzavo e sapevo che mi attendeva Levin che andava a cogliere il fieno mi sarei tagliata le vene, mi aspettavano tre giorni di face e falcetti, nomi specifici delle piante. Ma anche qui le rappresentazioni sono vivissime. Le similitudini sempre concrete: il male viene paragonato al mal di denti, la paura al ponte sopra il baratro. Non ci sono elucubrazioni filosofiche. Anche il suicido di Anna è semplice. Lei è convinta che lui non la ami e si suicida. Punto. In sei o sette righe si concludono novecento e più pagine di romanzo. In modo nitido, esatto. La noia in Tolstoj semmai arriva dopo, finita Anna Karenina, quando ha inizio la svolta più religiosa e sociale».
Personaggi preferiti?
«Mi divertivo come una pazza quando vedevo arrivare il principe Šcerbackij padre perché sapevo che avrei riso. Mi è molto simpatica la principessa Mjagkaja, la prima a dire che Karenin è un cretino. Io sono un po' alla Stanislavskij, quando traduco qualcosa ci finisco dentro con tutto il corpo. Ma sono solo due i personaggi che ho sognato: Oblonskij che mi chiedeva un prestito, ma non mi invitava fuori e questo un po' mi ha scocciato, e Karenin che si arrabbiava perché diceva che lo facevo più antipatico di quello che era».
La gioia più grande di questa traduzione?
«Quando un amico mi ha detto che ha regalato il libro alla nipote sedicenne e da tre giorni non riuscivano a staccarla. Accidenti! Qui sì che mi vengono i brividi».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo








