In viaggio tra i Chazari con Milorad Pavić il popolo mitico che sapeva leggere i sogni
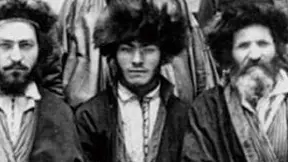
la recensione
Ci sono popoli il cui solo nome basta a evocare un mondo di leggende e saperi arcani, tanto più se la loro esistenza è stata quasi del tutto dimenticata, cancellata dai libri di storia. È quello che accade con il popolo di cui racconta il “Dizionario dei Chazari” di Milorad Pavić, ripubblicato dopo più di trent’anni da Voland (pp. 355, euro 20) nella bella e ariosa traduzione di Alice Parmeggiani.
I Chazari sono un popolo mitico, su di loro le fonti sono incerte e contraddittorie. Si dice fossero nomadi originari delle steppe dell’Asia centrale, che tra il IV e il X secolo si stabilirono tra il Mar Caspio e il Mar Nero. Che avessero parentele con i turchi e fossero abili pescatori, che sapessero leggere i colori come fossero note musicali, o numeri o lettere. Tutti concordano sulla loro abilità guerriera, sul fatto che adorassero il sale, e si dice che alcuni di loro avessero la capacità di leggere i sogni. Ed erano proprio questi cacciatori di sogni a essere tenuti nella più alta considerazione presso la corte del khan.
Non potrebbe esserci terreno più fertile per la penna di Pavić, esperto di dottrine esoteriche, grande inventore di mondi fantastici, con una fascinazione per quel confine ambiguo che separa la nostra realtà dai sogni. E questo “Dizionario” infatti non è un semplice libro, ma un gioco del mondo che, proprio come il romanzo “Rayuela” di Cortázar, invita il lettore a giocare e a perdersi tra le pagine, leggendole nell’ordine che vuole, non necessariamente dall’inizio alla fine. Perché, ci avverte il narratore, quello tra le nostre mani è solo una possibile versione del “Dizionario”, dal momento che il testo originale pubblicato nel Seicento da un ambiguo stampatore polacco è andato perduto. E così il gioco delle versioni così ci avviluppa da subito.
Al centro della storia c’è “la questione chazara”, cioè la conversione del popolo dalla religione originaria a una delle tre grandi fedi monoteiste. Quale di queste fedi sia stata la prescelta è materia di scontri e leggende, ma quel che si sa con certezza è che portò al collasso dell’impero chazaro. La vicenda ha inizio da un sogno del khan che, inquietato dalla visione, convocò a corte un derviscio, un rabbino e un monaco promettendo che avrebbe fatto convertire il suo popolo alla religione del saggio in grado di dargli l’interpretazione più convincente del sogno. Su come si svolsero i fatti non c’è concordia. E così il “Dizionario” prende la forma di una narrazione mitica. Spariscono i capitoli, sostituiti da voci enciclopediche che si rincorrono nelle tre parti in cui è divisa la storia: il libro rosso che raccoglie le testimonianze cristiane, il verde per le musulmane, e il libro giallo per le fonti ebraiche.
Il lettore entra in un labirinto di voci e gioca a perdersi tra i grandi cacciatori di sogni, Avram Branković di Transilvania, grande condottiero ed erudito, il liutaio turco Jusuf Masudi e l’ebreo Samuel Coen dall’unico baffo grigio. Una rete dei personaggi si tesse di libro in libro, come in un racconto da “Mille e una notte”, dando vita a incontri seducenti: la principessa Ateh, donna privata del suo sesso e che forse per questo vive in eterno, Nikon Sevast, lo scrivano che altri non è che il Satana cristiano, i maestri di sciabola e i dotti, i santi e i banditi.
Soffia tra le pagine di Pavić il gran vento della letteratura slava, con il suo confine sottile tra realtà e visioni mistiche, con la potenza delle radici cabalistiche, con la forza assordante di mille cavalieri al galoppo dalla steppa e la grazia dell’erudizione degli scribi di Costantinopoli. Un vento che ci riporta le storie di un Oriente alle porte di casa, di un Oriente dimenticato. E se a qualcuno venisse la tentazione di leggere nella tripartizione dei “Dizionario” un’allusione alle molte anime dei Balcani, Pavić forse alzerebbe le spalle, invitandoci a non cercare la realtà nella letteratura, ma a fare della letteratura la nostra realtà.
Leggere un libro grosso come questo, ci avverte infine, significa stare soli per lungo tempo. E allora allo scrittore rimane il senso di colpa per aver sottratto il lettore dal tempo con la persona amata, e si impegna rimediare. Per questo il “Dizionario” esiste in due versioni, una femminile e una maschile. Così lettore, invita Pavić, ora scendi in strada con la tua copia sotto il braccio, fallo il primo mercoledì del mese a mezzodì, e recati alla pasticceria della piazza principale della tua città. Là troverai un giovane o una giovane che come te si è appena sentito solo leggendo questo libro, potrete confrontare le vostre versioni, trovare l’unico punto in cui divergono e poi andarvene insieme, iniziare un’amicizia. O forse, insinua ancora l’autore, vi verrà il sospetto che quelle versioni che tenete in mano non siano le uniche due, e forse intuite di essere voi stessi parte di una Babele di libri e leggende, proprio ora che ve ne andate abbracciati sui sellini dei vostri velocipedi. —
Riproduzione riservata © Il Piccolo








