Ilaria Tuti: «Nel bosco domestico cerco le radici di nuove emozioni»

Esiste una parola per descrivere il profumo che la pioggia solleva dal terreno scaldato dal sole.
Petricore.
Pietra e icore, il sangue minerale che la mitologia greca racconta scorrere nelle vene degli esseri immortali.
Lo sento salire, quando le prime gocce, quasi grasse, ticchettano sulle zolle lavorate. L’acqua mescola polvere, geosomina e olii vegetali stillati dalle radici, e io torno bambina, mezzelune nere sotto le unghie e sulle guance il pizzicore della vita selvatica.
Il giardino era diventato una foresta. Negli ultimi tempi non se ne era preso cura nessuno: troppi impegni, molte ore trascorse fuori casa. Lo scorgevo dalle finestre, tra una pagina e l’altra di storie che stavo scrivendo, ci passavo quando il buio lo nascondeva. Nel frattempo, alberi e cespugli tessevano trame fitte, conquistavano spazi strappandoli all’addomesticamento. Un tempo se ne occupavano i miei genitori, ma mio padre non c’è più da anni e mia madre se ne è allontanata con dolore, perché coltivava questo giardino per lui. Ricordo che papà vi aveva lavorato fino al giorno prima di morire e il suo maglioncino era rimasto appeso ai rami nocchiuti del pero per settimane, prima che io trovassi il coraggio di raccoglierlo. Temevo il suo profumo, il finto tepore che la primavera aveva conservato tra le impunture e che non era quello del petto di mio padre. Quello non sarebbe mai più tornato.

C’è voluta una pandemia per farmi camminare di nuovo tra queste fronde, per riconsegnarmi il mio tempo. Anche il bosco domestico ha bisogno di respirare, e per farlo è necessario sfoltire. La mano che lo accudisce deve essere implacabile davanti ai getti superflui.
Di mano è rimasta la mia, ma non è più capace. Deve recuperare la conoscenza. Gli attrezzi irrigiditi dalla ruggine aprono vesciche e rendono dolenti le giunture delle dita spoglie.
L’aria si raffredda non appena una nuvola copre il sole. Le gocce hanno smesso di ticchettare. Non ha nemmeno iniziato a piovere.
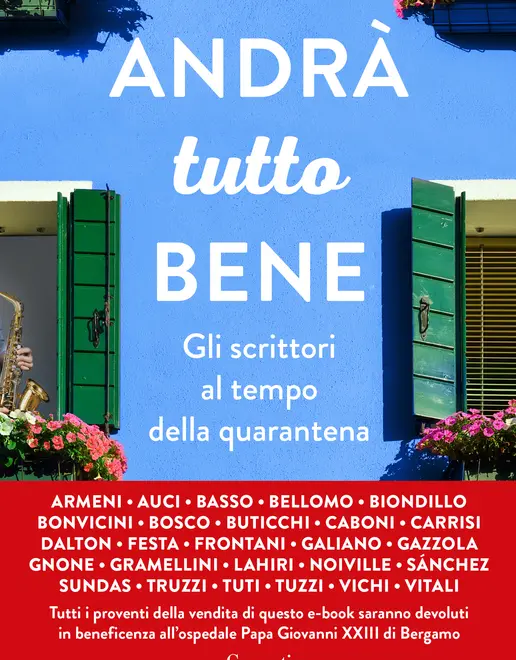
Ho tranciato rami e strappato radici, ho scavato, trapiantato e steso terriccio per ore. Raccolto foglie, bruciato sterpaglie, sollevato pietre e osservato un pettirosso osservare il mio lavoro. Quando mi allontanerò, lo vedrò bagnarsi nel piccolo stagno, come ieri. I pesci non si nascondono più quando arrivo. Aspettano il cibo sempre nello stesso punto, da generazioni. Quando ero bambina, offrivano il dorso alle mie carezze. Forse accadrà ancora.
So di fumo e di polvere, e dell’erba che mi tinge i palmi. A qualche passo di distanza, mia figlia impasta fiori e fango e prepara minestre immaginarie con l’acqua della fontana. La chiamo piano quando una rana sale in superficie per respirare o una lucertola si arrampica su un sasso, ma lei corre chiassosa e le fa fuggire. Non ha ancora imparato i codici silenziosi della natura.
È inevitabile pensare a chi è costretto tra le pareti di un appartamento, a chi è solo, a chi deve restare assieme a chi non ama, o ha imparato a temere, a chi ha l’esistenza torturata da una mente instabile. Ai bambini tolti alle amicizie e alle esperienze.
Le vie di fuga quotidiane sono state tagliate. Siamo prigionieri di un virus che toglie il respiro e lo consegna al nostro tempo, dilata le giornate. Se mancano le passioni con cui colmarle e l’equilibrio, è lo stesso che soffocare lentamente. Siamo chiamati a saggiare la tenuta dei nostri affetti, del mondo interiore che abbiamo fin qui nutrito e che è abitato da slanci altissimi quanto dalla nostra ombra. Un’ombra che nella solitudine si allunga enormemente e si appropria di una voce che nel silenzio dell’inattività è più che mai udibile.
Di tanto in tanto, mi fermo a valutare il lavoro fatto e mi sento calma. La fatica non permette alla paura di farsi avanti, né accorda terreno ai turbamenti. Il lavoro manuale concede una tregua alla mente, dà spazio al corpo togliendolo ai pensieri ricorrenti. Si percepisce la forza dei gesti, che è anche quella di cui lo spirito si arma.
Presto tornerò al lavoro, l’altro lavoro, quello distante dai silenzi e dai ritiri della scrittura. Lo farò con un certo timore. Mi chiedo se d’ora in avanti le distanze tra esseri umani saranno colmate dalla paura e dal sospetto, o se saremo capaci di gettare tra noi le radici di nuove connessioni emozionali.
Cambieremo, forse, oppure resteremo gli stessi, perché dimenticare è necessario per andare avanti. Di certo, cercheremo di non farci trovare impreparati la prossima volta.
Una farfalla cedronella danza tra i germogli delle rose antiche. In un libro di mia figlia è disegnata mentre solletica il muso di un dinosauro. Ho scoperto che in realtà questi insetti che per milioni d’anni divisero il mondo con i dinosauri non erano lepidotteri: geneticamente non avevano nulla a che vedere con le farfalle odierne, ma le ricordavano perfettamente per struttura, colori e forma. Si nutrivano del polline delle felci e degli alberi e si estinsero quando comparvero i fiori. Quarantacinque milioni di anni dopo la loro scomparsa, la natura replicò nuovamente la soluzione evolutiva che così a lungo si era dimostrata vincente e modellò la biologia molecolare delle nuove farfalle in modo tale che potessero convivere con i fiori. Si chiama “evoluzione convergente”. Nulla di buono viene gettato. Torna, modificato.
Anche noi terremo ciò che ci fa bene e ci libereremo del nocivo?
Forse sfronderemo le nostre esistenze, così come ora io sfrondo il verde perché respiri, affinché quanto di buono trovi spazio per svilupparsi grandiosamente.
Mi piacerebbe imparare a costruire qualcosa, ma soprattutto a riparare, invece che sostituire continuamente. Il benessere ci ha disabituato a conservare. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno finora è stato disponibile in infinite varianti, sempre pronte. Appena il timore di perdere anche solo uno di questi beni replicati in miliardi di copie si è affacciato ci ha fatto prendere d’assalto i negozi. La noia e la frustrazione ci fanno consumare cibo come mai prima. Riempiamo il vuoto lasciato dalle abitudini con materia. È successo anche a me.
Eppure discendo da un retaggio abituato a non sprecare nulla, quello del Friuli di pochi decenni fa. Un territorio e un popolo descritti con tenerezza malinconica da Pierluigi Cappello nel suo racconto Un dolore lungo un addio: una «cultura fatta con il culto delle mani rovinate, con i gesti che hanno attraversato i secoli, con le bestemmie a fior di labbra, con le novene, con la pena di Adamo e la nostalgia dell’Eden. Una cultura contadina e artigianale che sapeva sostenere con umiltà ma con occhi ben dritti e asciutti lo sguardo della vita e della morte».
Quello sguardo ben dritto ora deve essere anche il nostro e deve saper puntare lontano. Deve essere quello dei nonni che ora tanti stanno rischiando di perdere.
Continuo il mio lavoro. Si è alzata la bora, spazza le nubi. Le campane del duomo suonano a lutto nella luce di rena della tempesta respinta. Un altro funerale, con solo gli affetti più cari attorno alla bara, animi chini che proprio in questo momento avrebbero bisogno degli ab-bracci e delle parole della comunità per non soccombere alla disperazione e che invece si ritrovano soli.
La pandemia ci ha tolto anche i riti consolatori della morte e della vita.
Il mio paese accoglierà venti salme della provincia di Bergamo per il triste compito di cremarle. Il messaggio del sindaco ai cittadini è intitolato «Il Friuli e Gemona non dimenticano». Non dimentichiamo l’aiuto che le genti di quei luoghi hanno prestato al nostro territorio in occasione del sisma devastante del ’76. In questa infausta emergenza, la solidarietà ricevuta potrà essere in parte ricambiata. Si legge nella nota che questi nostri fratelli saranno accolti con grande affetto e che per ognuno di loro sarà posato un fiore. Sono sicura che non resteranno solo parole. Forse tra loro c’è qualcuno dei tanti bergamaschi che quarantaquattro anni fa hanno scavato tra le nostre macerie.
Impossibile non pensare al terremoto in questi giorni, quando anche la terra croata ha tremato in un’alba fredda. Nel colmo della pandemia, cinquanta volontari della Protezione Civile friulana hanno raggiunto Zagabria per allestire tende da campo e prestare i primi aiuti.
Sopravvivere, a volte, è semplicemente stringere mani in una lunga catena.
Questo è il momento del dolore e del lutto, del silenzio riparatore, ma verrà anche il tempo in cui la vita riprenderà a scorrere vivace e rumorosa nelle strade. La storia insegna che non può essere a lungo imbrigliata, nemmeno dalle catastrofi, nemmeno dalle morie più violente.
«Ho subito la guerra da bambino, il terremoto a metà della mia vita, ma mai avrei creduto di vedere questo, a ottant’anni», mi ha detto mio zio, più solo che mai ora che nessuno può andare a trovarlo.
Mi ha fatto pensare che appartengo a una generazione non abituata a lottare in massa per la vita; la morte, fino a qualche settimana fa, era un dramma che si compiva nell’intimità della famiglia, mentre ora si è presa il palcoscenico di un’intera nazione, e si replica in altre. Dobbiamo convivere con un senso di precarietà che prima d’ora avevamo sperimentato solo in altri ambiti.
«È tutto così feroce e così impalpabile», mi ha scritto Luca, un amico, confessando che sente smorzarsi il sorriso davanti al sole del mattino.
«Ho già visto la colonna notturna di mezzi militari per il trasporto delle salme» sono, invece, le parole di Michele. «L’ho già vissuta una volta quella cosa. Era nel campo sportivo di Sarno, e le bare erano disposte a terra.»
Era il 1998 quando l’alluvione si portò via sua madre in un fiume di fango e da allora vive con il padre, un uomo costretto a scegliere tra salvare il figlio o la donna che amava.
Michele mi ha confessato di non riuscire a provare paura, se non per suo padre. Ha già perso così tanto. La mamma, la sua casa, i libri e i fumetti tanto amati, l‘adolescenza. «Tutto in una notte.»
Ora più che mai sento l’esigenza di ascoltare per conservare la memoria di questo tempo.
Il sole scivola dietro le montagne in un silenzio irreale e io sono ancora qui, ad annusare la terra, a riempirmi di vento e di coraggio, per pensare al futuro di mia figlia senza tremare.
Il contagio ha cambiato anche il panorama. In lontananza, le ciminiere di una delle aziende più importanti del territorio non soffiano il vapore residuo della lavorazione del legno. Gli impianti sono spenti. Dei settecento dipendenti solo quattro sono rimasti a presidiare i due chilometri quadrati della fabbrica.
Ho immaginato le linee fermarsi, le centrali termiche spegnersi, come le luci nei reparti, una dopo l’altra. È la prima volta che accade per un’emergenza, nella lunga storia della fabbrica.
Un punto di riferimento dinamico e vitale per intere comunità ora è muto e immobile.
L’umanità si è sempre rialzata, penso. Lo farà anche questa volta, ma forse saremo chiamati a trovare nuovi paradigmi dentro i quali inscriverci e ripensare un modo nuovo di stare al mondo. Ci troviamo davanti a un cambiamento epocale, o forse è solo l’inusuale senso di provvisorietà a farcelo percepire come tale.
In questi giorni ho visto citate le parole che Aldo Moro pronunciò il 28 febbraio 1978 nel suo ultimo discorso davanti ai gruppi parlamentari, in uno dei periodi più angoscianti che l’Italia abbia vissuto in tempi recenti: «Se fosse possibile dire: saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a questo domani, credo che tutti accetteremmo di farlo, ma, cari amici, non è possibile; oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso, si tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà… Camminiamo insieme perché l’avvenire appartiene in larga misura ancora a noi».
Sembrano le parole di un guerriero. Sono talmente calzanti per la contingenza che stiamo vivendo da farmi credere ancor di più nella possibilità di attraversarla e ritrovarci migliori, perché è già accaduto e ancora accadrà.
Nella battaglia che stiamo conducendo non ci sono soldati in prima linea, ma personale sanitario e, subito dietro, le donne e gli uomini che ci fanno trovare a disposizione ogni giorno il cibo di cui abbiamo bisogno. Non dobbiamo dimenticarlo, quando sarà il momento, e verrà, di riconoscere il valore dell’opera di ciascuno.
Ho in mente le parole preziose che mi ha scritto in questi giorni Sarah Savioli. Sarah, per un periodo della sua vita, ha lavorato con i profughi vittime di torture e di quell’esperienza ricorda: «Pensavo che dovessero essere medicati, vestiti e nutriti, tutte cose pratiche. Invece la prima cosa che mi disse chi lavorava lì da sempre fu che era essenziale mantenere accesa o riaccendere in loro una fiammella di gioia, sennò sarebbe stato solo un ritardare lo spegnersi dei corpi. Così imparai che, mentre c’era chi disinfettava piaghe purulente e faceva iniezioni di antibiotico e vitamine, gli occhi di quegli es-seri umani si riaccendevano grazie a dei pastelli.
Ecco, quando questa tortura finirà, lascerà il nostro mondo sanguinante. La cultura, e gli scrittori parte integrante di essa, saranno e dovranno essere quei pastelli. Speriamo di poter essere dei buoni pastelli…».
Mi auguro, per quanto potrò, di saper dipingere alcuni momenti della vita di altri con colori luminosi.
Il sole è tramontato, ripongo gli attrezzi. La bellezza del giardino comincia ad affiorare. Domani sarò di nuovo qui.
L’orizzonte è di una purezza lucente, Venere splende solitaria e pare tremare al vento.
A volte mi sento disegnata dai profili neri delle montagne stagliati contro il cielo acceso di fuoco e zaffiro.
L’icore scorre anche dentro di noi, dopotutto. Apparteniamo alla terra e al mistero.
È un pensiero confortante.
Un respiro profondo. Andiamo avanti. —
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo








