Giombi, basso baritono: «Kleiber mi regalò il palco del Metropolitan per i miei 50 anni»
Lunedì l’artista al Museo teatrale Schmidl di Trieste presenta l’autobiografia “La mia strada nel bosco” con Bianchi e Gori
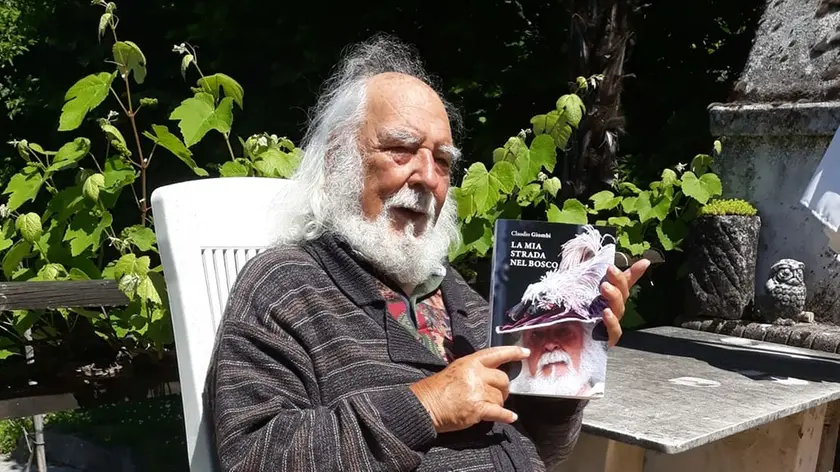
TRIESTE Probabilmente non ha saputo vendersi bene, come oggi va di moda dire (e fare). Perché la storia del basso-baritono Claudio Giombi davvero non
Articolo Premium
Questo articolo è riservato agli abbonati.
Accedi con username e password se hai già un abbonamento.
Scopri tutte le offerte di abbonamento sul nostro shop.Shop
Non hai un account? Registrati ora.
Argomenti:TRIESTE
Riproduzione riservata © Il Piccolo
Leggi anche
Video








