Gentile ucciso dai comunisti? Ma dietro c’era la Ghirlanda
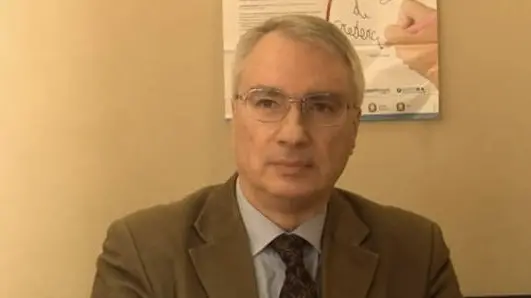
Emergono alcune significative novità sulla morte di Giovanni Gentile, assassinato a Firenze il 15 aprile del 1944. Il filosofo, organico al regime mussoliniano, aveva ricevuto nei giorni prima diverse minacce a causa del suo appoggio dichiarato alla leva per la difesa della Rsi (la Repubblica Sociale Italiana, il governo del duce sotto tutela dei tedeschi). A uccidere Gentile fu, quel giorno, un gruppo partigiano fiorentino di Gap (Gruppi di azione patriottica) di ispirazione comunista. Fu un episodio che divise lo stesso fronte antifascista e che ancora oggi è al centro di polemiche non sopite, venendo infatti già all'epoca disapprovato dal Cln (il Comitato di liberazione nazionale) toscano, con la sola esclusione del Partito comunista, che rivendicò l'esecuzione. Ora un libro di Luciano Mecacci - già docente di Psicologia generale all'Università di Firenze - riapre la discussione. Si intitola “La Ghirlanda fiorentina e la morte di Giovanni Gentile” ed è pubblicato da Adelphi (pagg. 520, euro 25,00).
Professor Mecacci, che cosa sappiamo oggi di certo sull'assassinio di Gentile?
«Darei per certo anzitutto quanto affermò il gappista fiorentino Giuseppe Martini, poco prima di morire nel 1999: a uccidere Gentile furono lui e un altro gappista comunista, Bruno Fanciullacci, sebbene io argomenti sulla base di numerosi indizi che a sparare fu il solo Martini. Martini riferì pure che gli ordini erano arrivati per via gerarchica dai propri capi, pur avendo l’impressione che i mandanti non fossero questi, ma si trovassero più in alto. Si trattava dei vertici del Partito comunista o di altre forze? Le ipotesi avanzate sono le più disparate: dai comunisti alla massoneria, dai fascisti estremisti ai servizi segreti tedeschi, da alcune componenti del Partito d’azione ai servizi segreti britannici».
Quali sono le scoperte scaturite dalla sua ricerca?
«Ho analizzato, da una parte, la dinamica dell’esecuzione, cercando documenti e testimoni; dall’altra, il comportamento degli intellettuali italiani, in particolare fiorentini, prima, durante e dopo la morte di Gentile. Si tratta di due aspetti che si sovrappongono, l’uno sfuma nell’altro. Per quanto riguarda l’esecuzione, anzitutto ho trovato rilevanti per comprendere tutto questo complesso scenario i documenti inediti che riguardano le indagini svolte, i testimoni interrogati (tra l’altro ho individuato un testimone che era rimasto ignoto fino ad oggi), la pseudoperizia balistica (su proiettili che molto probabilmente non erano quelli sparati su Gentile), le persone arrestate, alcune delle quali presto rilasciate (a parte i tre docenti universitari Bianchi Bandinelli, Calasso e Biasutti che rimasero in carcere per un mese circa). Va tenuto presente che mentre è conservato il fascicolo del giudice che condusse l’istruttoria, è sparito integralmente il fascicolo della Questura intitolato “Omicidio Gentile”».
È emersa la presenza di qualcosa d’inconfessato?
«Se l’esecuzione fosse stata solo un’operazione di matrice comunista, allora non si spiega tutta una serie di omissioni e depistaggi che caratterizzano questo episodio cruciale avvenuto durante la lotta di liberazione. Ciò ci spinge a ritenere che sia accaduto qualcosa d’inconfessabile, che appunto è poi rimasto inconfessato, e che potrebbe coinvolgere sia i fascisti sia gli antifascisti in una sorta di accordo, più o meno tacito, nell’eliminazione del filosofo. Si pensi che nel 1989, quando ormai i nomi dei gappisti erano noti e la vulgata dell’attentato (i comunisti come mandanti ed esecutori) era data per consolidata, il filosofo Cesare Luporini, già senatore Pci, disse che vi erano cose che “forse ancora non si possono dire”. Un’affermazione di non poco conto dalla quale sono partito nella mia ricerca, scandagliando fin dove mi era possibile un intreccio di persone e posizioni politiche nella Firenze di quei mesi, una rete che ho chiamato “ghirlanda fiorentina”, prendendo in prestito il nome dal titolo di un taccuino di un italianista scozzese, agente dei servizi segreti britannici, in missione a Firenze durante la visita di Hitler nel maggio 1938».
Quale fu la posizione dell'intellighenzia di allora? Si può parlare di una responsabilità morale?
«Io penso che l’esecuzione di Gentile sia stata un’azione di guerra, finalizzata all’eliminazione di un possibile attore scomodo nel conflitto in corso, e tanto più una volta che questo fosse terminato. Ebbene, niente da eccepire dal punto di vista morale rispetto a chi aveva fatto determinate scelte per la liberazione del Paese dai fascisti e dai tedeschi, a condizione però che questa scelta fosse fatta apertamente. Ma in questo modo trasparente agirono solo pochi intellettuali. La maggioranza, giustificandosi in seguito nelle forme più svariate, manifestò la propria fedeltà allo stato fascista (si ricordi il comportamento dei professori universitari riguardo il giuramento del 1931) o si espresse in tiepide manifestazioni di fronda. Molti di questi intellettuali erano legati a Gentile chi come allievo, chi come collaboratore della Enciclopedia Italiana, e molti di questi, appena morto, dichiararono la loro estraneità al pensiero e al progetto culturale del filosofo. A mio avviso, la responsabilità morale dell’intellighenzia di quegli anni è più in questa lezione di trasformismo e sciacallaggio che è stata consegnata alle nuove generazioni. Ecco perché termino il libro con le lapidarie parole di Eugenio Montale, scritte a Firenze nell’ottobre 1944: “E quale educazione politica potrà venire a un popolo che ha simili maestri? La tragedia è che, personalmente, siamo tutte persone ineccepibili. Non si credeva, non si sapeva, non si voleva. E intanto la bufera è venuta”».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo








