Fuga da Trieste verso la Luna
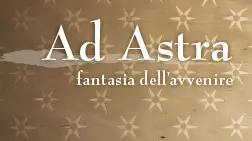
di CRISTINA BENUSSI
N. el 1883, per i tipi del Lloyd austro-ungarico, Francesco de Grisogono, ventiduenne nato a Sebenico che aveva frequentato l'Accademia della Marina imperiale, pubblicava a sue spese uno studio dal titolo avveniristico: “Sulla possibilità di navigare gli spazi celesti”. Studio basato sopra la scoperta dell'oscillante, ovvero un mezzo fisico per volare nel vacuo. Le sue ardite teorie non trovarono credito nella collettività scientifica, ma destarono la curiosità e conquistarono la stima di Antonio Bersa de' Leidenthal allora direttore dell'«Osservatore Triestino». Organo di informazione economica, commerciale e politica, il quotidiano si occupava anche degli ultimi sviluppi della scienza e della tecnologia, i cui temi venivano tanto più dibattuti quanto più alta era l'attesa di un futuro radioso. Lo prometteva senza ombra di dubbio quella cultura positivistica che stava gettando le basi del decollo industriale europeo.
Ebbene questo dalmata di lingua italiana, avvocato e presidente del collegio dei periti riguardo ai diritti d'autore, si era appassionato anche allo studio delle scienze matematiche e fisiche. Dalle pagine del suo giornale non solo prese le difese di Francesco de Grisogono, che tra l'altro sarebbe diventato il nonno materno di Claudio Magris, ma invitò pure i lettori a un dibattito aperto ai tanti temi affrontati in quel saggio. Erano gli anni in cui nasceva la fantascienza e Julius Verne con i racconti di viaggi fantastici dentro e fuori la terra ne era il massimo rappresentante.
Antonio de' Bersa non resistette alla tentazione di emularlo, e nel 1884 dette alle stampe un libro, che ruotava attorno a Triestre, in cui immaginava che lo studio di de Grisogono sarebbe stato ritrovato duemila anni dopo nei recessi polverosi di una biblioteca, permettendo così all'umanità di provare l'esperienza straordinaria di un viaggio sulla luna: un bibliofilo eccentrico, una figlia risoluta e un ingegnere di talento avrebbero attuato quel progetto visionario che i contemporanei non avevano compreso. Giustina Cartoni: fantasia dell'avvenire si intitolava quel racconto pubblicato a Trieste dall'editore Schubart. Venne poi ristampato a Milano da L. F. Cogliati nel 1898 con il titolo “Ad astra: fantasia dell'avvenire” e nel 1903 come “Idillio lunare”. Le edizioni milanesi, salvo il titolo e le copertine, sono identiche tra loro, ma differiscono da quella triestina, che riportava elementi paesaggistici e toponomastici troppo legati all'immaginario cittadino, e commenti scientifici che forse non sarebbero più stati attuali quattordici anni dopo.
L'esistenza di tre titoli ha tuttavia confuso più di uno studioso, convinto dell'esistenza di tre romanzi diversi. Certamente, come ben argomenta Jacopo Berti, curatore della nuova edizione appena uscita per Zona 42 (pagg. 236, euro 11,90), il testo presenta svariati elementi tipici del genere fantascientifico, quali non è sempre facile trovare negli emuli di Verne, tra l'altro qui puntualmente citato. L'autore, infatti, non solo riporta elementi della attualità scientifica a lui contemporanea, in campo meteorologico, chimico, meccanico, delle scienze naturali, ma descrive anche possibili soluzioni tecnologiche per permettere ai suoi astronauti di sopravvivere nell'atmosfera lunare.
Antonio de' Bersa probabilmente era ben lontano dal considerare sensata la reazione dei decadenti che, sul versante umanistico, avvertivano i propri lettori del rischio cui si esponeva l'umanità: affidare il proprio futuro a un'ideologia che metteva in secondo piano problemi di ordine etico e spirituale. Tanto è vero che anche le similitudini per descrivere i moti dell'animo di individui e gruppi li aveva attinti nell'ambito scientifico, quello elettrico-magnetico. Ma era l'epoca delle grandi esposizioni universali, dell'elettricità che modificava il vivere quotidiano, della velocità della comunicazione come faceva prevedere l'invenzione nel 1880 del fotofono, con cui Bell era riuscito a convertire i suoni in segnali luminosi, e con cui i nostri protagonisti riuscivano a coprire distanze siderali. E non era l'unica invenzione moderna di cui potevano disporre. Ma, a ben guardare, più fantascientifico delle soluzioni tecniche era il progetto con cui l'autore immaginava di risolvere i rapporti tra le diverse collettività umane che popolano la terra. Sempre pensando che la velocità e la semplificazione della comunicazione siano il toccasana per appianare i dissidi e facilitare la comprensione, prevedeva l'affermarsi di una lingua universale, acquisita infine da un'umanità pacificata sotto le ali protettive degli Stati Uniti Terrrestri e di una corte internazionale di arbitri. Ma per quanta fantasia potesse avere, neppure uno scrittore di fantascienza poteva immaginare come quell'utopia si sarebbe potuta inverare.
Antonio de' Bersa non solo anticipa una tematica che oggi siamo chiamati ad affrontare con urgenza, ma anche quella con cui domani sarà inevitabile fare i conti: insomma ci parla del ruolo dell'impresa privata nella conquista dello spazio. Stilisticamente e linguisticamente datato, “Ad astra” svela tuttavia la complessità di una visione del mondo paradossalmente non lontana da quella che aveva per certi versi ispirato il decadentismo europeo.
Anche Jacopo Berti, studioso che frequenta abitualmente la nostra Biblioteca civica, vi ha trovato casualmente l'unica copia sopravvissuta del testo originario. Ha scelto tuttavia di ripubblicare la versione e il titolo del 1898, “Ad astra”, più vicino all'immaginario di un genere che è da tempo entrato di diritto nel corpus letterario. Il restyling stilistico ci ha restituito un testo in cui, al di là di alcune indubbie ingenuità narrative, emerge il richiamo forte e sincero a non consegnarci a un futuro che de' Bersa certamente auspicava, ma che forse anche temeva: e questa è la più attuale delle fantascienze.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo








