Esperimenti e cavie umane dai medici del Terzo Reich all’incubo dell’eugenetica
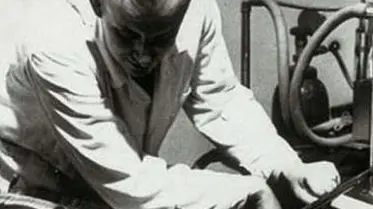
la recensione
La follia del nazismo continua, a tanti anni di distanza dai fatti che sconvolsero l'Europa, a sconcertare e a far sorgere in noi domande cruciali e angoscianti. Alcune di queste riguardano l'ambito della medicina. Come poterono tanti medici, durante quel regime, trasformarsi in carnefici? Perché trattare altri esseri umani come oggetti? E come mi sarei comportato io al loro posto? Ecco i quesiti che si sono posti gli autori dei saggi raccolti da Federica Scrimin e Tristano Matta nel volume “Medicina e Shoah. Eugenetica e razzismo del Novecento. Parentesi chiusa o problema aperto?” (EUT, pp. 287, euro 18) pubblicato dall'Università di Trieste in occasione della Giornata della Memoria 2021. Si tratta di un volume scritto a più mani in cui storici, genetisti, psichiatri, ginecologi, giuristi e bioetici si sono messi in discussione ripensando all’esperienza della medicina in epoca nazista. Il tema era stato al centro di un significativo convegno tenutosi a Trieste nel 2013. Per definizione i medici si occupano della cura del prossimo e sono legati al giuramento di Ippocrate. La partecipazione attiva di tanti medici tedeschi e austriaci a uno dei più atroci crimini della storia dell'umanità ci turba e sembra inspiegabile. Oltretutto a quel tempo la medicina tedesca era all'avanguardia. Occorre inserire quei fatti nel loro contesto e gli autori del libro ci aiutano a farlo illuminandoli da diversi punti di vista. Gli anni Trenta dello scorso secolo vedevano grandi progressi della conoscenza medica, tra i quali la scoperta degli ormoni, della genetica, gli studi sui batteri e sui gruppi sanguigni. Sembrava il trionfo dell'approccio positivista che poteva promettere soluzioni facili a problemi complessi. A molti, non solo in Germania e in Austria, sembrò di poter toccare il cielo della medicina con un dito. Tutto pareva possibile: addirittura migliorare la specie umana. “Wir sind nicht allein (non siamo soli)”, dicevano i medici nazisti, consapevoli che le teorie mediche evoluzionistiche, insieme a quelle razzistiche, avevano permeato gran parte della medicina internazionale. Spesso si dimentica che anche la Gran Bretagna, la Svezia, gli Stati Uniti approvarono leggi che regolamentavano i matrimoni o imponevano la sterilizzazione di “minorati”, “criminali abituali”, “deviati”, tutte categorie che fra l'altro erano ben poco definite dal punto di vista scientifico. Soprattutto le scoperte relative alla genetica e all'evoluzione sembravano destare l'interesse di vari stati, e non solo del Terzo Reich. Punto di partenza per capacitarsi di come certe atrocità poterono verificarsi sono gli atti del processo di Norimberga del 1946-47 riguardanti i medici nazisti. Il libro racconta che la medicina tedesca e austriaca fu in misura non piccola coinvolta in derive etiche e comportamenti tragici. Il più delle volte il tradimento del patto tra medico e paziente non fu il risultato della follia di singoli professionisti ma della smania di privilegiare in modo spregiudicato le esigenze sperimentali e la necessità di “ottenere risultati a tutti i costi e di guarire” anche per motivi bellici. Il periodo nazista coincise con un’epoca in cui la medicina, in particolare quella tedesca, aveva ottenuto importanti successi, c'era ansia di sperimentare sia per migliorarsi sia per ottenere onori accademici e carriera. I campi di prigionia e sterminio potevano fornire un numero illimitato di cavie umane e molti cattedratici o aspiranti tali ne approfittarono senza farsi troppi scrupoli, sostenuti in questo dall'ideologia nazista cui in molti avevano aderito. Ne approfittarono anche varie industrie farmaceutiche tedesche che finanziarono studi specifici su cavie umane. Sui prigionieri ebrei, polacchi, russi, spesso soppressi quando non servivano più, si scrissero tesi di laurea e di specializzazione. E l’Italia? Il nostro Paese ebbe un atteggiamento più prudente: ad esempio l’eugenetica venne vista come il prolungamento della politica di espansione demografica, pratica che comprendeva l'igiene sociale (come la lotta alla tubercolosi, alla malaria e all’alcolismo), la tutela della famiglia e dell’infanzia, l'incremento della natività. La sterilizzazione rimase un reato anche in epoca fascista, come ricorda Pierpaolo Martucci citando il Dizionario italiano di Criminologia edito da Vallardi nel 1941. Ma l'approccio rimaneva pur sempre “razziale” e ne fecero le spese soprattutto gli ebrei. Vari autori del libro sottolineano che, nel compiere le proprie scelte professionali - specie in campo eugenetico, i medici di oggi devono confrontarsi con la sofferta storia della medicina nel secolo scorso e porsi in modo bioeticamente responsabile. Una delle cose più importanti, suggeriscono, è la pratica del consenso informato, ossia il coinvolgimento dei pazienti nelle scelte di cura che li riguardano. Compito del medico è informare, aiutare a scegliere il percorso di cura più idoneo e poi accompagnarlo in questo percorso. In tal modo il rapporto medico-paziente si umanizza. Guardandosi negli occhi, suggerisce lo psichiatra Michael von Cranach, uno dei primi a documentare il coinvolgimento della medicina nella Shoah, è più difficile che la relazione di cura diventi prevaricazione. La preparazione tecnico-scientifica e l'empatia rimangono sempre la migliore garanzia per una buona medicina. —
Riproduzione riservata © Il Piccolo








