Era musica degenerata l’unica voce di resistenza degli artisti vittime dei lager
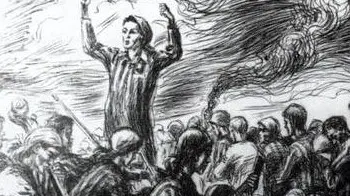
i saggi
I regimi nazista e fascista la definivano musica “degenerata” perché considerata decadente, dannosa e contraria ai canoni nazionalisti. Venne ufficialmente perseguitata e alla fine dimenticata. Così come i suoi compositori, a volte già famosi, esclusi dai cartelloni teatrali dopo la promulgazione delle leggi razziali e cancellati dalla storia della musica. Alcuni riuscirono a sfuggire alle persecuzioni e continuarono a comporre nei paesi in cui trovarono rifugio, dando vita alla "musica dell'esilio". Altri vennero deportati nei campi di concentramento, dove, in contrapposizione a quella - oppressiva e stranianate - imposta dagli aguzzini, per sopravvivere a terrore e sconforto scrissero partiture attraverso cui esprimere le loro paure e speranze, tentando di scordare, per un momento, la vita del ghetto. La musica diventa così forma di protesta e resistenza e descrive un frammento della terribile quotidianità del lager.
L'unica voce delle vittime assume il nome di musica "concentrazionaria": un documento che può aiutare a conoscere e interpretare la Shoah. Da qualche anno finalmente alcune di queste storie sono state riportate alla luce. E Trieste, dove si tiene l'unico festival europeo, il Viktor Ullmann, dedicato alla musica concentrazionaria, degenerata e dell'esilio, contribuisce attivamente a quest'opera di rivalutazione, anche grazie ad Alessandro Carrieri, uno studioso tornato in città dopo aver vissuto per sei anni a Melbourne come Visiting Research Fellow in Holocaust Studies presso l’Australian Centre for Jewish Civilisation.
Ora, gli atti triestini di un convegno internazionale realizzato proprio nell'ambito del festival diventano un libro, con in copertina la riproduzione di un dipinto del triestino Arturo Nathan. Esce per i tipi della casa editrice inglese Palgrave Macmillan (www.palgrave.com) - a fine mese in formato ebook e a maggio in versione cartacea - "Italian Jewish Musicians and Composers under Fascism – “Let Our Music Be Played” (“Musicisti e compositori ebrei italiani sotto il Fascismo – “Lasciate che la nostra musica venga suonata”) a cura di Annalisa Capristo, attiva al Centro studi americani di Roma e autrice di numerosi saggi sulla persecuzione e Alessandro Carrieri, studioso dell'esilio degli intellettuali, artisti e musicisti ebrei durante il fascismo e nazismo, ricercatore dell’Università di Trieste.
Il volume raccoglie vari saggi che accendono i riflettori sulle discriminazioni subite dai musicisti e compositori ebrei italiani, per la maggior parte versioni ampliate delle relazioni tenute in città nel 2015 durante il convegno organizzato dal Festival Viktor Ullmann, promosso da Musica Libera, e dall'Università - Dipartimento di Lettere e Filosofia in collaborazione con Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi.
Per ora la pubblicazione è disponibile solo in inglese, ma si sta pensando anche a un’edizione italiana. «Ci sono voci di musicisti che continuano a essere inascoltate: quelle – spiegano i curatori del libro – dei compositori ebrei italiani nell'Italia fascista. Durante quel periodo furono esclusi dai teatri, dalle orchestre, dai conservatori, dalle case discografiche e dalla radio e le loro composizioni bandite e bollate come musica degenerata».
Coinvolgendo studiosi di diversi campi per analizzare e ricostruire - in modo completo e multidisciplinare - l'impatto che le leggi razziali e le relazioni tra la Germania nazista e l'Italia fascista ebbero sulla vita e le opere di quei compositori dal '33 al '45, il libro intende far conoscere a un vasto pubblico le storie di questi artisti, oggi quasi del tutto dimenticati. I documenti raccolti offrono pure una visione più ampia del rapporto tra musica e regimi totalitari. Erik Levi analizza quello tra Italia fascista e Germania nazista, rivelando che finché l'alleanza culturale tra i due regimi non fu così stretta, gli italiani continuarono talvolta a sfidare la propaganda nazista, tenendo spettacoli e promuovendo musica proibita dai tedeschi, come il jazz.
Camilla Poesio ne descrive la diffusione in Italia nonostante gli sforzi per impedirlo e l’attribuzione al genere di matrice afroamericana dell’etichetta di "musica degenerata". Attraverso i giornali d'epoca Luca Levi Sala analizza l'atteggiamento della critica musicale verso i musicisti ebrei italiani, dimostrandone non solo la violenza culturale, ma il fatto che contribuì significativamente alla diffusione del razzismo nella società. «Abbiamo deciso di realizzare questa pubblicazione - proseguono Capristo e Carrieri - perché negli ultimi decenni sono stati pubblicati lavori che hanno analizzato l'espulsione degli ebrei italiani da vari settori culturali, professionali e politici, ma c’è stata poca attenzione per i musicisti. L’approccio usato la rende inoltre accessibile anche ai non addetti ai lavori».
Il libro si apre con una panoramica di Michele Sarfatti sulla situazione degli ebrei italiani al momento dell'introduzione delle leggi razziali.
Capristo ricostruisce gli eventi che portarono all'espulsione dei musicisti ebrei dai teatri italiani. Carrieri compie un'analisi comparativa delle esperienze di esilio del compositore Renzo Massarani e del pianista Gualtiero Volterra, di cui questo lavoro rappresenta il primo studio. Raffaele Deluca infine fa luce su un caso poco noto di attività musicale nel campo di Ferramonti di Tarsia, in Calabria, dov'era internato il compositore austriaco Kurt Sonnenfeld. —
Riproduzione riservata © Il Piccolo








