Così Graziana Pentich trasformò in amore l’inquietudine di Gatto
Mondadori raccoglie in un Oscar “Tutte le poesie” dell’autore che visse per poco a Sistiana nel 1953
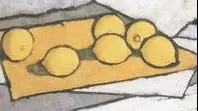
Si dice che i poeti siano degli inquieti, dando al termine un’accezione di spirito, più che fisica. Con Alfonso Gatto, però, il primo tipo di inquietudine si coniuga nell’altro. Difficile individuare, nel corso del Novecento italiano, un poeta che più di Gatto sia sia mosso da una città all’altra, da una regione all’altra, fino a quei viaggi come inviato dell’«Unità» che l’hanno portato a nord e a est dell’Europa.
Inquieti i suoi spostamenti, a caccia di lavoro, di amicizie, di letteratura, forse soprattutto a caccia di quella verità che nelle sue dichiarazioni di poetica, assomigliava tanto alla parola “resistere”. Resistere al fatto di essere sempre in procinto di catturare qualcosa che non sarà mai nostro: «Resistono i poeti alla perenne approssimazione della verità». Vederla e sentirla, scriveva Gatto, non significa ancora averla raggiunta.
Inquieti i suoi scritti, tra poesia, prosa, riflessione critica, testi raccolti ora nel nuovo Oscar
“Alfonso Gatto. Tutte le poesie” (Mondadori, pagg. 812, euro 26)
, curato da Silvio Ramat. Inquieta la sua arte. A differenza degli altri intellettuali dell’epoca, Gatto si ostina ¬– precedendo la contemporaneità – a declinare la sua opera in una frenetica attività interdisciplinare.
Gatto è stato poeta, pittore, romanziere, critico d’arte e di letteratura, addirittura attore in quel “Vangelo secondo Matteo” dove Pasolini lo volle nel ruolo dell’apostolo Andrea, mentre in “Teorema” gli affidò la parte di un medico. E inquieto, come ogni poeta, lo è stato nell’amore. Tre le donne importanti nella sua vita, la prima fu la moglie Jole Turco che sposa nel 1934, il matrimonio durerà una decina d’anni. L’ultima fu la giovane Paola Minucci. Ma sarà la triestina Graziana Pentich l’amore della sua vita.
Si erano incontrati nel 1946 a una conferenza di Marcel Raymond su Valery, a Milano. Da allora non si separarono, convivendo fino al 1960. D’altra parte, Graziana Pentich corrispondeva perfettamente al suo profilo: anche lei poeta e pittrice, investita nell’arte con la stessa passione e disciplina, amante dei viaggi e delle avventure, un temperamento inquieto come quello di molte donne del Nordest: autonoma, colta, curiosa.
Insomma, per la Pentich è stato naturale seguire Gatto nei suoi innumerevoli viaggi, sempre insieme, e al contempo trovare il tempo di occuparsi anche della propria arte. La pittrice infatti ha pubblicato raccolte di liriche (con Mondadori), ha curato cataloghi. E gli ha dato due figli: Leone e Teodoro.
E qui torniamo a una poetica che molto ha a che fare con l’amore e, di conseguenza, con la tragedia. Perché certo, Gatto è stato poeta di forti inquietudini, prime tra tutte quelle dell’amore e della morte. Fin troppo facile evocare Leopardi, a cui Gatto deve molto. Ma appunto, va detto che dalla sua prima raccolta “L’isola” (1929) fino a “Desinenze” (1976), la morte è il fil rouge della sua opera. E la fine, in qualche modo, è segno che gli rimane impresso fin da bambino. Innanzitutto con la scomparsa del fratellino Gerardo, che comparirà costantemente nei suoi libri, soprattutto in quella che è ritenuta la raccolta più complessa: “Morto ai paesi”. Ma la fine lo colpirà anche con la perdita del figlio Teodoro, nel 1962, per cui scriverà “Il vaporetto”, tra i libri più belli di tutta la letteratura per l’infanzia, riedito poi in una versione accresciuta con le illustrazioni di Graziana Pentich.
Graziana, dopo la morte del poeta e del figlio Leone (suicida pochi mesi dopo la scomparsa del padre), raccoglierà la loro memoria nel magnifico “I colori di una storia” (Scheiwiller), un libro commovente, dove i disegni di Alfonso e Leone testimoniano il bene quotidiano in piccoli gesti domestici.
Tornando alla poetica, la morte non sempre assume quei toni tragici che troveremo nelle “Poesie della Resistenza”, dove emerge il Gatto più civile e politico. Piuttosto, sia nella produzione precedente che successiva al 1966, la perdita si confonde in un’epica ambigua, dove spesso è associata all’amore: amore e morte incarnano un assoluto di sentimenti, di memoria, di affetto collettivo che non andrà perduto. Per cui dice bene Silvio Ramat: «Le liriche di morte diventano le più cariche d’amore». E d’altra parte non si pensi che nelle tante “Poesie d’amore” dedicate a Graziana, non vi siano intensi richiami al trapasso. Ma è un distacco che traduce appunto l’apice dell’affetto, il senso della morte sono innanzitutto i “nostri” morti: il suo passato, scrive Gatto in una delle poesie più intense: «Ha tanti morti che l’amore/più non basta al ricordo, né la voce». Inevitabile non ricordare il Luzi che dà un senso di comunità pacifica ai morti e ai vivi.
E inquieto fu il suo stile, certo riconducibile, almeno all’inizio, ai codici dell’ermetismo. Per fluire poi in dimensioni più surreali, talvolta anche realiste, sempre vocate, per lo più, a una forma chiusa. Ma a pensarci, Gatto è sempre stato incline a dei denominatori comuni, nonostante le inquietudini. Così la sua poetica rimane piuttosto coerente, i suoi temi, le sue ansie, sempre esplicitate nelle “lettere” di accompagnamento alle liriche. Così fu per la sua vita, nonostante il temperamento insofferente, ma dalle idee chiare. Pronto a non redigere mai una verità definitiva, consapevole che non si raggiungerà mai la propria immagine (così nelle “Rime di viaggio”), ma con dei punti fermi, pagati di persona. Nel 1936 sarà arrestato per antifascismo e la prigionia nel carcere di San Vittore, l’isolamento, la meditazione e la presa di distanza da ogni gratuito nichilismo gli farà scrivere: «Noi siamo responsabili della vita degli altri».
Ma al di là delle vittime di guerra, del distacco dettato da motivi storici, sarà sempre il dolore per la perdita degli affetti a dettare il passo dei suoi versi più alti, della poesia più alta che mai sia stata ideata per un padre: «Un uomo vivo col tuo cuore è un sogno», scriveva in “Se mi tornassi una sera accanto”. O ancora, per Teodoro, il figlio perso prematuramente: «Irrompi a testa bassa nel ridere, fanciullo, devastaci la vita e un’altra volta vivi».
Allora c’era sempre Graziana a suo fianco, che lo seguì ovunque, soprattutto in quella Milano che Gatto, nato a Salerno, amava sopra ogni altra città. Graziana intanto andava e veniva da Trieste, solo per un breve periodo il poeta stazionerà nel capoluogo giuliano, a Sistiana, nel 1953. In fondo è sempre stato un fanciullo, Alfonso Gatto, un uomo con il cuore di fanciullo, anche se Pascoli non era proprio nelle sue corde. Non come Leopardi, Ungaretti e Rimbaud almeno. E ai ragazzi ha dedicato parte della sua opera.
In questa nuova edizione aggiornata si possono trovare venti inediti. Ma soprattutto quasi tutte le poesie per bambini, quel “Sigaro di fuoco” (1945) poi confluito nel “Vaporetto” (1963), lì dove l’intelligenza stringe l’occhio all’anarchia: «Non date retta al re/non date retta a me/ chi v’inganna si fa sempre più alto di una spanna». E, infatti, è sempre andato di moda Rodari, di scritture più caute e moderate. Ma Gatto era abitato da una spasmodica voglia di vita, consapevole che l’amore e la morte ci tengono compagnia: «la contemplazione dell’amore e la contemplazione della morte sono nel nostro sguardo. Sono il nostro sguardo». E di lui è questo lo sguardo che rimane, quello di chi ha indagato ogni anfratto della vita, senza perdere una goccia di sangue, con passione, vitalità, adesione. Insomma, un poeta.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo
Leggi anche
Video








