Collodi, il giornalista combattente che amava divertire
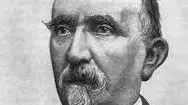
Tra i libri italiani noti a livello globale, uno dei più celebri sono senza dubbio Le avventure di Pinocchio, edite in volume nel 1883, opera per l'infanzia, destinata però a non esaurirsi nel consumo immediato dei bambini dell’epoca: tra i capolavori della letteratura universale, la storia del burattino di legno, tradotta in ogni lingua, gode di una popolarità straordinaria, che non accenna a diminuire un secolo e mezzo dalla pubblicazione.
Paradossalmente, però, la fama di questo testo ha finito quasi per oscurare la figura dell'autore. Nato a Firenze nel 1826, Carlo Lorenzini assume lo pseudonimo di Collodi dal borgo toscano vicino a Pescia di cui era originaria la madre. A lungo la sua figura è stata oggetto di una certa mitizzazione: i biografi tendevano a sottolineare l'estrema povertà della famiglia di origine, il suo sguardo, sin da piccolo, sull'opulenza di un nobile casato fiorentino, e dunque il precoce svilupparsi in lui di un'istintiva intolleranza nei confronti delle ingiustizie e discrimazioni. Tutto vero, ma Collodi, ben prima della stesura di Pinocchio, è stato molte cose.
È per questo che Rossana Dedola parte dalla vita nel saggio “Pinocchio e Collodi. Sul palcoscenico del mondo” (Bertoni editore, pagg. 282, euro 18,00), ricostruendo nel primo capitolo proprio la biografia dello scrittore. Fervente mazziniano, volontario alle prime due guerre d’Indipendenza, nel 1860 è impiegato a Firenze, prima presso la Commissione di censura teatrale, poi presso la Prefettura. Ha intanto iniziato la sua collaborazione a giornali locali, facendosi apprezzare per l’arguta vena realistica e per la vivacità dell’ironia. Traduttore delle fiabe francesi del Seicento (tra cui quelle di Perrault), Collodi si specializza, a partire dal 1875, nella scrittura di opere destinate a bambini e ragazzi. Quest’attività, premiata dal favore del pubblico, continua fino alla morte, che avviene a Firenze nel 1890.
Oltre al capolavoro per il quale è universalmente noto, Collodi può insomma vantare una lunga carriera di giornalista e scrittore. Nell'ambito della prolifica produzione per l’infanzia cui si accennava vanno ricordati i romanzi pedagogici Giannettino (1877) e Minuzzolo (1878), cui seguono veri e propri libri di testo per le scuole elementari. Tutte opere accolte con favore dal pubblico, che però non ottennero l'approvazione ministeriale, una sorta di "bollinatura" indispensabile per garantire un sicuro successo di vendite. Perché lui si poneva l'obiettivo di insegnare divertendo e questo, evidentemente, mal si accordava alle seriose teorie pedagogiche del tempo. A giudizio del Ministero, infatti, i testi di Collodi - come leggiamo nella motivazione del diniego all'approvazione - erano «concepiti in modo così romanzesco da dar soverchio luogo al dolce, distraendo dall'utile; e scritti in stile così gaio, e non di rado così umoristicamente frivolo, da togliere ogni serietà all'insegnamento».
Il saggio di Rossana Dedola presenta poi altri due capitoli, dedicati rispettivamente a una lettura critica di Pinocchio e a una disamina della fortuna di quest'opera nella musica, nel teatro, nel cinema. A prima vista la vicenda del protagonista, un piccolo scapestrato che alla fine di mille peripezie si redime diventando buono e aiutando il vecchio padre, rientra nella morale consolatoria della borghesia di fine Ottocento. Il ritorno all’ordine del burattino, frattanto diventato bambino in carne e ossa e pronto a tramutarsi in cittadino modello, esemplifica il classico lieto fine. Eppure, molti aspetti destabilizzano il moralismo del libro, rendendone la ricezione più complessa: l'opera è, insieme, storia di formazione, romanzo picaresco, narrazione d'avventura, compresa una certa dimensione “nera” (i temi della violenza e della morte), cosa non così scontata in un libro per ragazzi. —
Riproduzione riservata © Il Piccolo








