Cent’anni di Slataper un’anima in tormento a metà tra due culture
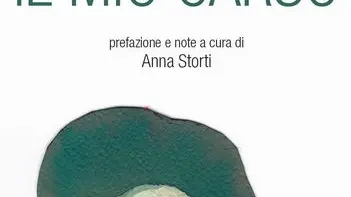
di Mary Barbara Tolusso
Forse nessuno ha incarnato un modello artistico preciso come alcuni autori triestini. L'artista triestino, più di altri, nel corso della storia forgia la sua scrittura non sul rifiuto delle contraddizioni, quanto piuttosto sulla loro assimilazione e rielaborazione. L'arte nasce sempre, in fondo, da un forte contrasto, da un energico dinamismo.
Al "tipo triestino" dunque un'arte fatta di Carso e luci della città, dura pietra e liquidità marina, cultura tedesca, italiana e slovena, commercio e belle lettere. Slataper incarnerà la contraddizione all'eccesso, con la sua stessa vita, da un certo punto di vista il più alto rappresentante di una generazione che, nonostante i conflitti, praticò più che la letteratura come vita, la vita come letteratura. Svevo lo fece giorno per giorno, restituendo il suo essere borghese tutto intero in quel mondo di carta. Saba con la pratica di quella “poesia onesta” che non solo teorizzò. Ma Slataper, lui che provocò più di altri l'italiana Trieste negandole “tradizioni di cultura”, lui pur così consapevole della necessaria coesistenza delle due anime della città, non esitò ad arruolarsi nel Regio esercito italiano e morì al fronte sul Monte Podgora, il 3 dicembre del 1915. Ed è in occasione del centenario della sua morte che il Centro Studi Scipio Slataper, insieme alle università di Trieste e Udine e all'Istituto Giuliano di storia, cultura e documentazione, organizza il convegno “Voglio morire alla sommità della mia vita”. L'evento sarà articolato su due giornate, domani e venerdì, a Trieste e a Gorizia, dove verranno approfondite tematiche riguardanti la figura intellettuale di Slataper e il suo pensiero politico.
Ma la novità è anche un'altra. Per questo anniversario la Transalpina Editrice ha inteso pubblicare una nuova edizione del capolavoro di Scipio Slataper, "Il mio Carso", un elegante tascabile con cover firmata da Ugo Pierri, di facile lettura con la prefazione e le precise note di Anna Storti, ritenuta tra i maggiori studiosi dell'autore triestino. «Il volume inaugura una una nuova collana, denominata “L'Elleboro Verde” - spiega Storti - dedicata alla narrativa di qualità, in particolare del territorio». Slataper si fece conoscere molto presto, con quelle “Lettere triestine” diffuse dalla rivista “La Voce” nel 1909 (con cui lo scrittore collaborò intensamente) e con analisi e articoli di politica per “Il Resto del Carlino”.
Un percorso, il suo, che nella pur breve durata ha perfettamente coniugato tensione politica e letteraria confluendo nell'opera principale. “Il mio Carso” riassume infatti tutti gli elementi della poetica slataperiana: la devozione per la donna amata (quell'Anna Pulitzer il cui suicidio portò lo scrittore al più violento contatto con la sofferenza e con l'idea della morte), l'amore per una nazione e per una patria. E qui si distinguono i due concetti di appartenenza: quella nazionale, possibile secondo Slataper per comunanza di lingua e cultura, mentre al Carso è destinata l'idea di patria, intesa come luogo dell'anima, di tipicità e tradizione, fusion. e di nazionalità e sangue, nel rispetto delle diversità, da cui l'attualità del discorso slataperiano di una patria proiettata in Europa. Le antinomie tra la città e il Carso divengono quindi anche allegoria di una modernità complessa e inquieta, i cui contrasti devono essere metabolizzati, prima che superati.
Come per molti autori triestini, “l'anima in tormento” che Slataper diceva di aver ricevuto da Trieste, potrebbe essere la stessa “aria tormentosa” di Saba, come osservò Elvio Guagnini nella sua "Città d'autore". E tormentata è anche la cifra stilistica, sempre alta, tra romanzo psicologico, confessionale, lirico e filosofico, a rimarcare i conflitti, le contraddizioni e i contrasti della differente Trieste. Ma qui, in questa nuova edizione, Storti ci mette a parte in maniera accurata di ciò che potrebbe essere più ostico: «Per questa curatela ho pensato al mio lettore ideale - dice - uno studente della scuola secondaria o un lettore appassionato, ma non triestino».
Ecco perché tra le note ci sono spiegazioni esaustive non solo di analisi storica e filologica, ma anche delle tradizioni locali, di italianismi derivati dal dialetto della città. Del romanzo, l'unico che Slataper riuscì a scrivere a causa della morte prematura, rimane netta la sensazione del contrasto, giocato a più livelli. Soprattutto quel riverbero tra vita e arte. Lo scrittore è stato tra gli uomini che hanno conosciuto il peso della morte dell'amata, per di più suicida. Non basta. Nel biglietto che Anna Pulitzer lasciò, c'è scritto a chiare lettere che è un gesto compiuto per la realizzazione dell'opera di Scipio. Un tragico gesto, come ci spiega Anna Storti, che fa riflettere molto l'autore sui rapporti tra vita e arte, o meglio su quella letterarietà che aveva inquinato la sua relazione sentimentale con Anna: cioè la ricerca di risultati artistici invece di sincerità interiore.
L'ossessione letteraria può portare anche a questo, a meno che non raggiunga la geniale consapevolezza di Proust. Ma Trieste non è Parigi, tanto meno quella primonovecentesca, quella che Slataper configura come città che dà ai suoi figli un'anima in tormento e per questo è amata. Tormentati, i triestini, lo rimangono sempre, pur in assenza di quei conflitti politici e identitari, come se la città continuasse ad amare solo le contraddizioni, solo ciò che è in conflitto: «È indubbiamente un elemento fondamentale della cultura triestina e c'è qualcosa di intrigante in tutto questo: la sfida che ognuno deve mettere in atto per superare ostacoli e antinomie». Slataper, per stile e biografia, rimane forse tra gli scrittori triestini che più esprimono il contrasto tra natura e cultura, tra vitalità barbarica e civiltà, tra anarchia individualista e impegno sociale, tra essere italiani e non esserlo, insomma tra tutte quelle tensioni morali che sono andate a costruire il mito della triestinità. Ma oggi, cosa può dire Slataper a un giovane? «Rimane il libro di un ragazzo che sta cercando la sua strada, sostenuto da contrasti interiori. E oggi che forse tra i giovani c'è meno passione e meno forza, "Il mio Carso" dà la possibilità di un confronto ideale».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo








