Carlo Lucarelli: «A Trieste ho aperto “La porta rossa” e svelato i suoi lati nascosti»
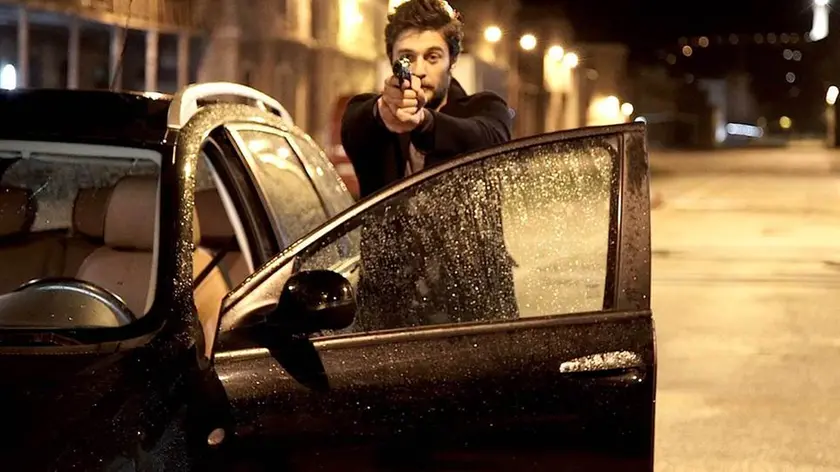
TRIESTE Una vera e propria maratona di cinema, tv e letteratura lunga due giorni con protagonista una voce che da anni li coniuga con successo: è quella che propone tra oggi e domani l’Hotel Victoria che, a conferma della sua vocazione culturale, si regala per i suoi dieci anni un salotto letterario con qualcosa in più. Dalle 18 alle 24 di oggi i tanti fan di “La porta rossa” potranno ripercorrere le vicende del commissario Cagliostro della prima stagione. L’amata serie tv proseguirà domani dalle 12 fino alle 18 quando, a dialogare con la giornalista Elisa Grando e con il presidente della Film Commission Fvg Federico Poillucci, arriverà proprio il suo ideatore Carlo Lucarelli: un’occasione per scoprire anche i suoi ultimi due romanzi.
“La porta rossa” ha fatto emergere una Trieste marcatamente noir: che tipo di suggestioni le ha ispirato questa città?
«Quando - risponde Lucarelli - con Giampiero Rigosi ci siamo messi a pensare alla serie inizialmente il soggetto era indipendente da una precisa città di riferimento o, se proprio ce ne doveva essere una, poteva essere Bologna, essendo entrambi di là. Poi però abbiamo iniziato a considerare delle alternative e la produzione ce ne ha proposto un paio: c’era Trieste, che dal punto di vista produttivo offriva molti vantaggi. Vediamo se funziona, abbiamo pensato, aprendo una finestra sulla vostra città e iniziandola a conoscere molto meglio. Funzionava in modo incredibile! È cambiata addirittura la storia e la sceneggiatura si è adattata alla città, si è aperta. Ho trovato un mix di suggestioni perché Trieste era perfetta per la vicenda raccontata: è stato un vero incontro. L’atmosfera, l’idea della frontiera, il porto, il fascino misterioso, anche nelle sue tradizioni; è una città che può essere osservata dall’alto dal protagonista, ha i suoi lati nascosti e offre suggestioni a 360 gradi».
Si aspettava una risposta così entusiastica? Cosa ritiene abbia catturato di più il pubblico?
«Non sapevamo che avremmo ottenuto un successo di questa portata. Credo abbia funzionato un equilibrio magico tra l’aspetto noir della storia, il giallo, la tensione ma contemporaneamente anche la parte emotivo-sentimentale del rapporto tra i personaggi, il legame tra chi è morto e chi è rimasto. Quante mail e post su facebook abbiamo ricevuto! Parlavano proprio di questo aspetto: ho perduto una persona cara, mi sono rivisto nei vostri personaggi. Questo è stato molto importante».
È Cagliostro l’Uomo Che Cerca, come dice in “Navi a Perdere”? O è lei quell’Uomo?
«Io? Non lo so: io sto lì da parte. In genere nel giallo c’è il detective e il morto: in Cagliostro invece abbiamo fuso detective e morto insieme. È un Uomo Che Cerca al di là di quella che è la vita: potrebbe andarsene ma non lo fa, è ancora lì a cercare. È un personaggio importante, contraddittorio: prima non può andar via, poi non vuole. Lino Guanciale ci ha messo tutto il resto: ha avuto un grandissimo successo, quel personaggio, perché lo ha interpretato lui».
E il commissario De Luca? Lo ha fatto nascere quasi 30 anni fa con “Carta Bianca”, facendo seguire altre due opere ravvicinate. Poi lo ha tenuto in panchina per undici anni, per poi uscire con “Intrigo Italiano”. Oggi con “Peccato Mortale” vuole chiarire dei conti in sospeso. Quali?
«Ho cominciato il primo romanzo con un Uomo Che Cerca ma che ha un problema: ha combinato qualcosa durante il passato regime fascista per cui è ricattabile, c’è sempre qualcuno che vuole portarlo fuori strada. Ho proseguito con una serie di romanzi cercando di capire qual era il rapporto con se stesso: in “Intrigo Italiano” fondamentalmente De Luca l’ha capito, ha capito cosa farà da grande. Rimaneva un punto interrogativo: cos’ha combinato per ridurlo a essere precario, ricattabile, impossibilitato a fare veramente ciò che vuole fare, il poliziotto. Allora sono tornato indietro al’43, provando a vedere qual era il peccato mortale del mio commissario: e per tre quarti sono riuscito a capirlo. Nel prossimo romanzo spero di riuscire a comprenderlo del tutto».
Parla di «viaggio esistenziale» per andare alle origini di un tormento che non lo abbandona mai. Ma che personaggio è De Luca, uno che «non si capisce se in vacanza va al mare o in montagna»? Ambiguo o solo figlio del suo tempo?
«È un figlio di tempi eterni in Italia, perché a me pare che a livello esistenziale sia come parecchi italiani; forse lo sono anch’io, non so. Quella frase sottolinea che il mio commissario non ha un credo politico. Si giustifica dicendo “sono solo un poliziotto”, a dire “non centro niente con la politica”. La mia domanda, che ho sempre fatto in tutti i romanzi del commissario, è: possiamo dire “non c’entro niente, sto solo facendo il mio mestiere”, quando intorno succedono cose importanti che richiedono una presa di posizione. C’è chi lo ha fatto in maniera anche molto netta: ma lui non lo fa mai. Avrebbe dovuto chiedersi: ma che tipo di poliziotto sono e che tipo voglio essere? Ma non succede mai, ed è questo il suo peccato mortale, e questo è anche il peccato mortale di molti di noi italiani».
Quella di trattare i tempi del fascismo è un’esigenza dettata anche dal momento storico che stiamo vivendo?
«Sicuramente sì: spesso, e lo fai anche inconsapevolmente, parli del passato perché c’è qualche legame col presente. È vero che siamo tornati a parlare di fascismo, di razzismo, di leggi razziali: abbiamo sempre continuato a farlo ma senza farci i conti direttamente. Non è un caso se ho voluto parlare di un anno come il’43, pieno di aspettative e transizione, dov’è caduto un regime e non si sa cosa verrà dopo, dove la gente aspetta qualcosa di importantissimo. Un momento di totale confusione: certi meccanismi sono quelli di sempre, e di oggi in particolare». —
Riproduzione riservata © Il Piccolo








