Bjorn Larsson: «L’identità oggi è un’ossessione la specie umana scompare»
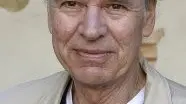
l’intervista
Gertrud Zander nasce nel 1928 a Trieste da genitori ebrei. Sopravvive ad Auschwitz e sceglie di diventare Maria, mamma single di un figlio che per sua volontà e solo dopo la sua morte sarà informato della vera storia della madre. Da lì incomincia per Martin Brenner il doloroso viaggio nella scelta di un’identità lungo cui ci accompagna in “La lettera di Gertrud” (Iperborea, pagg. 457, euro 19,50, traduzione di Katia De Marco) il grande scrittore svedese Bjorn Larsson. Martin è un genetista cinquantenne, ha una moglie amata, una figlia amatissima. La libertà di scelta che la madre gli ha lasciato, essere o non essere un ebreo, lo spinge prima di tutto a studiare tutto ciò che trova sulla ebraicità. Lo fa in modo scientifico, approfondito, sperando di poter decidere razionalmente prima di condividere la nuova realtà con chi ama.
Parliamo di questo formidabile libro con l’autore, che giovedì lo presenterà a Pordenone, nell’ex convento di San Francesco alle 18, ospite dell’associazione Thesis, e venerdì, alle 18, alla libreria Lovat di Villorba.
Larsson, lei è stato spesso definito uno “scrittore di mare”, ma ha rivendicato il diritto di scegliere qualsiasi soggetto di cui sentisse l’urgenza. Quale urgenza sta alla base di questo libro?
«Diciamo che non è un’urgenza di attualità immediata, si tratta di un romanzo non di giornalismo, ma è un’urgenza un po’ più a lungo termine, legata all’odierna ossessione per l’identità. Qualcosa che è iniziato quindici, vent’anni fa. Adesso siamo a un punto in cui tutti rivendicano la propria identità di gruppo, di tribù, di partito, di sesso, al punto che l’idea stessa di specie umana sembra scomparire».
Quest’ossessione nasce dal pensare a quello che si è piuttosto che cercare il coraggio di affrontare la paura per quello che si può o si vuole diventare?
«Sì, forse è la paura che proviamo davanti a un mondo che è diventato troppo grande… Prima, ad esempio, non esisteva l’attualità in diretta. Pensiamo all’incendio di Notre Dame da cui siamo stati coinvolti in prima persona davanti allo schermo. Vent’anni fa ci sarebbe stato un articolo di giornale il giorno dopo… Oggi ci si rinchiude per proteggersi anche emozionalmente, ma non funziona».
Bisogno di appartenenza e paura che qualcosa ci costringa a cambiare stanno al fondo dell’odio per chi non ci somiglia?
«Sì, ma seguire questo pensiero porta alla catastrofe. Pensiamo all’amore, l’amore non è una questione di genetica o di chiusura: è sempre un’apertura. La cosa che mi dà molto fastidio, e penso la dia anche a Martin nel romanzo, è che l’amore è svalutato e che è diventato una cosa da tribù piuttosto che un’apertura, come è sempre stato. E pensiamo alla libertà. Libertà è prima di tutto la capacità di immaginare che si può vivere diversamente, pensare diversamente. Quindi è una questione quasi mentale su cui naturalmente intervengono il contesto, la società… La libertà assoluta non esiste».
Lei cita in un suo lavoro Flaubert, che diceva che un libro dev’essere bello e buono. Pare però che in definitiva per lei il contenuto sia più importante...
«In Flaubert c’è tanta attenzione per la bellezza della lingua, ma se questa bellezza prende il sopravvento si può rischiare di perdere il contenuto. È un equilibrio molto difficile da raggiungere. Ma prendiamo come esempio Primo Levi, “Se questo è un uomo”: non è un “bel” libro è un “gran” libro. Se uno lo giudicasse per la sua “bellezza” sarebbe, non so, quasi come trascurare le vittime. Direi che tra forma e contenuto si tratta di scrivere sul filo di un rasoio».
In questo libro lei alterna con grande efficacia delle parti che sono quasi saggio per la gran quantità di testi di riferimento e di citazioni, e altre molto più intime che parlano della quotidianità di Martin, la sua famiglia, le sue amicizie.
«Credo che in questo senso sia un libro non unico, naturalmente, ma diciamo raro. D’altra parte bisogna capire che Martin è uno scienziato e lo scienziato ha questo tipo di approccio alla realtà. Bisogna essere fedeli alla personalità del personaggio».
La letteratura soffre di un’epidemia di calo di immaginazione?
«È una tendenza abbastanza chiara, nel senso che tutto è basato sulle storie vere. Penso ad esempio ai “romanzi” di Saviano, non è una critica, solo un’osservazione. Molti vogliono fare un libro sulla verità con il prestigio del romanzo. Forse dipende dal fatto che siamo immersi in fake news, docufiction eccetera e alla fine la verità ritorna in primo piano… diciamo piuttosto Primo Levi che Tolstoj. Ma sarebbe un peccato perché per me la letteratura è immaginare possibilità».
La preoccupa il mondo in cui viviamo?
«Troppo, troppo per la mia serenità. E non penso di essere l’unico. Dacia Maraini mi ha chiesto di scrivere per Nuovi Argomenti su come rapportarsi alla marea di informazioni che ci sommerge quotidianamente. Come possiamo accogliere emozionalmente tutto quello che sentiamo ogni giorno? D’altra parte scegliere comporta cinismo... La mia paura più grande, però, è per i giovani: se perdono la speranza, se perdono la gioia di vivere, il rischio diventa molto grande. Loro non possono arrendersi, devono andare avantI». —
Riproduzione riservata © Il Piccolo








