«Mio papà, Franco Basaglia»
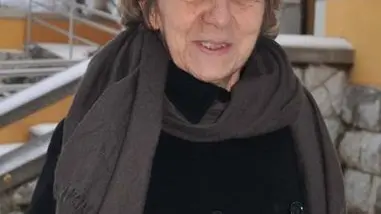
C’era un uomo che lo aspettava al bar di piazzale Roma. Ogni volta che Franco Basaglia tornava a Venezia lo trovava lì. Si chiamava Toni, ma scherzando dichiarava di essere il «miracolo Basaglia». Perché quelle conversazioni del sabato pomeriggio con lo psichiatra, che stava smantellando il manicomio di Gorizia, lo aiutavano a tenere lontani i fantasmi della mente. A non naufragare quando arrivavano le crisi.
Bevuto il caffè, salutato il signor Toni, Franco Basaglia entrava in quel suo piccolo territorio di libertà assoluta a Venezia. Poche ore più tardi, si sarebbe rimesso al volante. E cantando a squarciagola canzonette come “Nessuno mi può giudicare”, avrebbe riportato la famiglia a Gorizia. Non prima di avere consumato la cena di rito al ristorante “Sot la Nape” di Latisana. Appuntamento obbligato che Alberta Basaglia lascia riaffiorare in mezzo a un fiume di ricordi nel libro “Le nuvole di Picasso. Una bambina nella storia del manicomio liberato”, scritto con la giornalista veneziana Giulietta Racanelli e pubblicato da Feltrinelli (pagg. 96, euro 10).
E la cosa più bella di questo libro è che i ricordi non hanno filtri. Non conoscono censura. Spalancano le finestre sulla famiglia Basaglia raccontando i grandi progetti, il sogno di togliere i matti dell’inferno dei manicomi e le piccole avventure di ogni giorno. Come quella di abituarsi a vedere le cose in maniera laterale. Che Alberta Basaglia ha scoperto molto presto, visto che in fondo ai suoi occhi c’erano delle lesioni che la costringevano a osservare il mondo con la testa piegata da un lato. Gli altri dicevano che sarebbe diventata cieca. I suoi genitori non l’hanno mai accettato. E avevano ragione.
Un giorno, casa Basaglia era piena di amici di Franco e della moglie Franca Ongaro. Quelli che Alberta vedeva come i nuovi cavalieri della Tavola Rotonda. Sempre pronti a parlare, discutere, ragionare, per ore, senza mai stancarsi. Tra loro c’era un’altra bambina, che guardandola si era lasciata trasportare dalla curiosità: «Ma tu perché guardi con la testa storta?». Immediato, tra i grandi, era sceso un silenzio imbarazzato. Nessuno riusciva a formulare uno di quei discorsi “politically correct” per disinnescare la sfacciata domanda.
Fu Alberta stessa, che disegnava le nuvole come Picasso, a cavarsela con estrema semplicità: «Perché ci vedo meglio». Risposta in linea con l’educazione ricevuuta in casa. Da un papà che si fermava per ore a ragionare con lei su come vedesse gli oggetti. Da una mamma che la lasciava sciare e poi le chiedeva: «Ma come fai?». E lei tranquilla: «Chiudo gli occhi e vado».
Non c’era la tivù in casa Basaglia, però si ascoltava musica a tutte le ore. Mozart e Vivaldi, ma anche canzonette, canti di protesta. E poi, di tanto in tanto, arrivavano i matti. Persone impossibili da dimenticare, come Velio, che per anni aveva sognato di dipingere i muri con i colori della sua fantasia. E che a casa del «dotor» si era potuto sbizzarrire, dipingendo una parete di blu e una di arancione. Lasciava che i pennelli sgocciolassero in totale libertà sul pavimento dell’appartamento assegnato al direttore del mani. comio dalla Provincia. Un’infilata di uffici dai soffitti altissimi che si erano trasformati in una delle case più aperte e ospitali della città. E Gorizia, allora, era divisa da un muro, come quello di Berlino.
Basaglia che non si stanca mai di girare per i robivecchi di Venezia. E che contratta fino a spuntare lui quello che vuole, portandosi a casa i mobili di cui si innamorava. Basaglia che, per non addormentarsi al volante, caricava un autostoppista, sulla via del ritorno a Gorizia, quando non c’era la famiglia a fargli compagnia. E chiedeva: «Sai guidare?». Per cedergli in fretta il volante, e addormentarsi accanto a lui come un bambino. Basaglia che in spiaggia, al Lido, non riusciva mai a rilassarsi al sole, ad addormentarsi cullato dal tepore della sabbia. E finiva per restare perfettamente vestito, le Clarks ai piedi, con l’unica concessione all’ambiente marino: i pantaloni rimboccati fino alle ginocchia. Dopo cinque brevi, contemplativi minuti, era già pronto a partire: «Be’, adesso andiamo?».
Basaglia che aveva una mamma, la mitica nonna Cecilia, disposta a farlo arrestare dalla polizia fascista. Pur di non vederlo precipitare dai tetti di Venezia per farsi alla fuga. Una donna che la nipote Alberta dipinge con parole di ammirazione. Capace di andare al Teatro La Fenice con la sottoveste sotto la pelliccia, per non irritare il marito con i suoi preparativi infiniti. Senza per questo vergognarsi. E il bello è che del periodo partigiano, dei mesi passati in carcere insieme all’amico che l’aveva denunciato, Basaglia non parlava mai.
Per lui, il passato contava poco. Era nel presente che si doveva lavorare, lottare. Così Basaglia, che riusciva a sposare in modo sacrilego la psichiatria alla filosofia, che si sentiva più attratto dalla Scuola di Francoforte che dai padri nobili della medicina, ha finito per inseguire tutta la vita la costruzione di una possibilità. Quella da dare a tutti, maschi e femmine, matti e malati, bambini e handiccapati, per poter vivere la propria vita. A Gorizia era finito quasi in esilio, visto che all’Università di Padova non sapevano che farsene di quel sognatore. E tra le mura del manicomio si era trovato chiuso in prigione. Tra camicie di forza, catene, letti di contenzione. Tra persone che avevano consumato la propria vita dietro le sbarre. Trattate come oggetti. Senza un sorriso, una carezza, un minuto di gioia. Di umanità.
Il Sessantotto è stato un periodo davvero strano per Alberta Basaglia. Gli altri contestavano i genitori, distruggevano il mito della famiglia. Lei si ritrovava per papà lo psichiatra osannato dal Movimento. Una vera rockstar di quegli anni. Difficile non essere gelose di lui, visto che tutte le studentesse sgomitavano per conoscerlo. E la mamma? Franca Ongaro, nel libro, giganteggia come una donna dalle idee chiare, rivoluzionarie. Capace di alternare ai saggi le favole per bambini. Sempre pronta a sferruzzare dei maglioni fatti a modo suo. Rigidissima nell’imporre una moda assai in linea con la Swinging London, a tracciare la strada per i figli con grande rigore e convinzione.
L’ultima parte del libro, Alberta Basaglia la riserva a sé. Alla sua scelta di studiare psicologia, alle sue ricerche sui bambini sepolti nei manicomi. Dimenticati lì fino alla morte. Se fosse ancora vivo, Franco Basaglia le manderebbe un telegramma simile a quello che spedì per la sua laurea. Con due parole soltanto: «Brava, papà».
alemezlo
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo








