L’esperto: "Tragedia non annunciata. Ora pensiamo a difenderci"

TRIESTE Solo 20 anni fa, per sapere ciò che a poche ore dalla catastrofe della scorsa notte abbiamo già capito, ci sarebbero voluti alcuni giorni. Oggi, sono bastate poche decine di minuti. La sismologia ha fatto passi da gigante. Purtroppo, quasi soltanto nella misura di questi fenomeni mentre accadono e nel calcolo di un'infinità di parametri dopo che sono accaduti. Abbiamo fatto invece solo piccoli progressi nella previsione dei terremoti a priori. Continuiamo a non essere capaci di prevedere quando esattamente e quanto grandi saranno le scosse del futuro. Sul "dove" accadono più di frequente abbiamo le idee più chiare perché abbiamo individuato le aree più pericolose ed è obbligatorio costruirvi in modo antisismico. Ciò non toglie, purtroppo, che terremoti molto rari nel corso dei millenni possano verificarsi anche in zone mai colpite negli ultimi duemila anni (e non dichiarate ufficialmente sismiche).
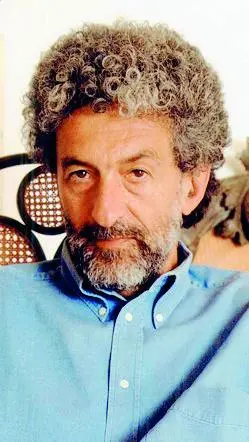
EDILIZIA ANTISISMICA
Basterebbe avere buone case antisismiche, si dice, giustamente. Certo: case nuove antisismiche e vecchie ristrutturate. Si potrebbe fare molto, anche perchè oggi l'ingegneria sismica fa quasi miracoli, ma non si riesce a fare abbastanza prevenzione. Perché? Intanto, per motivi economici. Nei comuni colpiti oggi, ad esempio, la stragrande parte delle case erano antiche, spesso addirittura disabitate o quasi. Ma anche per ignoranza. Ignoranza nel senso che molti di noi preferiscono spendere in arredamento, elettrodomestici, accessori elettronici, addirittura domotica (la casa telecomandata), invece di impegnare i risparmi per rinforzare la propria casa. (Ma diciamocelo: in condizioni normali, coordinare un condominio per ottenerne la ristrutturazione antisismica è un'impresa praticamente impossibile).
IL TERREMOTO DI IERI
Del sisma di ieri abbiamo potuto valutare dopo pochi minuti l'entità dell'energia sismica scatenata: molto all'incirca, la metà dell'energia del terremoto dell'Aquila del 2009; tradotto in magnitudo Richter, fa una piccola differenza: ieri magnitudo circa 6, nel 2009 circa 6,1 (è una scala logaritmica). Conosciamo il punto in profondità nella crosta terrestre in cui è iniziata la rottura e anche il meccanismo della rottura. In generale, una faglia si è già rotta ripetutamente in tempi geologici precedenti. Inizia a rompersi nuovamente quando gli sforzi accumulatisi nella crosta superano di nuovo le resistenze d'attrito e la cementazione naturale che ne avevano provvisoriamente sigillato la superficie di rottura.
Ieri, la nuova frattura è partita da una piccola parte della faglia a forse 4 chilometri di profondità, all'incira sotto il paese di Accumoli. Si può ipotizzare che in profondità la rottura possa essersi propagata in misura consistente verso nord-ovest (i colleghi ne stanno calcolando la "direttività" proprio in queste ore). È infatti in quella direzione che gli strumenti hanno registrato le accelerazioni del suolo più alte: circa la metà della accelerazione gravità, lo stesso valore massimo registrato ad esempio durante il terremoto del Friuli del 1976. Tenete presente che di solito non si riesce a restare in piedi, se queste vibrazioni così forti sono portate da frequenze che hanno durata di una singola oscillazione ("periodo") tra poco meno di un decimo di secondo a circa un secondo.
LE FAGLIE DELL'APPENNINO
Ieri il terremoto ha colpito la zona in cui Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo si incontrano. La regione è stata già sede negli ultimi decenni di piccole serie di scosse ("swarm" o "sciame") senza conseguenze. Ad esempio, circa all'estremità sud-orientale dell'attuale rottura, nel 1996 si verificò uno sciame con magnitudo massima circa 4. A proposito: a L'Aquila la scossa distruttiva fu preceduta da una serie di scosse, che durò dei mesi. Ieri, niente, una botta senza preavviso (almeno senza preavviso registrabile dagli strumenti dislocati in zona).
Al di sotto dell'area colpita ieri, nella crosta terrestre si è prodotta una frattura lunga circa 25 chilometri ed estesa tra forse un paio di chilometri di profondità fino a 8-10 chilometri sotto terra. Forse già in queste ore i geologi ci diranno se la frattura ha raggiunto la superficie del terreno, come avvenne in Irpinia e Basilicata nel 1980, mentre pare non avvenne nel 1976 in Friuli. In sostanza, ieri si è verificato un evento simile a quelli accaduti nel 2009 nella regione de L'Aquila, e in Umbria nel 1997 durante il terremoto cosiddetto di Colfiorito. E come nel 1997 e nel 2009, anche il piano di rottura (faglia) di ieri era orientato in direzione nord-ovest sud-est (la direzione della catena dell'Appennino centrale); e di nuovo, proprio come nei due casi precedenti, il meccanismo della rottura è stato dovuto al fatto che, nella lunga fase geologica in cui viviamo, il versante adriatico della catena si sposta verso est-nord-est (di un paio di millimetri all'anno), mentre la parte che dà sul Tirreno rimane relativamente ferma. In altre parole, il Mare Adriatico va restringendosi di un paio di millimetri all'anno. Queste faglie profonde dell'Appennino consentono insomma a tutta la catena di allargarsi leggermente.
LA STORIA SISMICA DELLA ZONA
Questo movimento sta andando avanti da molti milioni di anni e ha provocato spostamenti orizzontali complessivi della catena montuosa di decine-centinaia di chilometri. Così, la vasta fascia di territorio tra le quattro regioni citate, colpita ieri, è stata già sede di parecchi terremoti distruttivi negli ultimi due millenni.
L'area gravemente danneggiata ieri notte era già stata severamente colpita il 7 ottobre 1639. Uno dei centri più disastrati, Amatrice, nel 1639 aveva ad esempio subito danni valutati dal catalogo citato al IX grado () della scala di intensità "tipo Mercalli".
LA CHIESA DI AMATRICE
La storia sismica dei nostri paesi si legge addirittura sulle facciate dei nostri edifici storici. Guardate nell’immagine a sinistra si presentava fino all’altro ieri la bella Chiesa romanico-gotica di San Francesco ad Amatrice, della seconda metà del ’300. Le frecce sovrapposte all’immagine mostrano che dopo il terremoto del 1639 si dovette ricostruire tutto l’alto frontone, sostituendo il bel rosone originario. Ebbene, ieri la chiesa ha subito nuovamente il crollo patito quasi quattro secoli fa. Notate che si è anche riaperta la lesione verticale formatasi già nel 1639 (indicata dalle frecce più sottili) e che aveva anche spaccato a metà uno dei conci di pietra.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © Il Piccolo








