Fra il telelavoro e lo smart working un salto culturale su cui serve investire
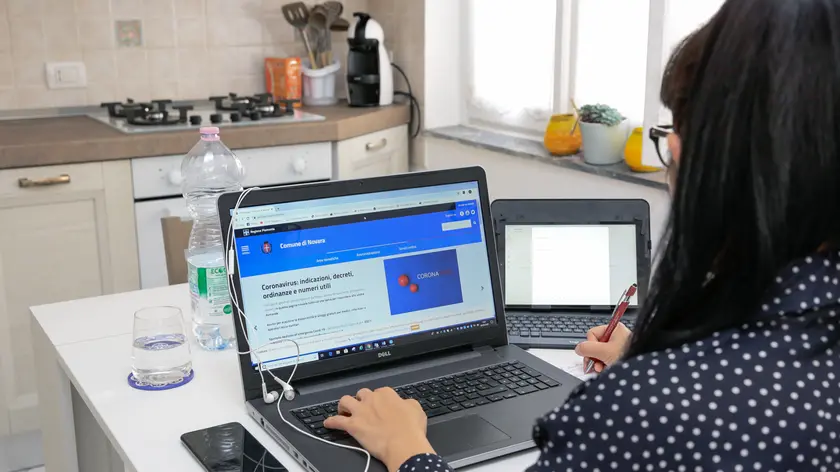
TRIESTE Smart working è la nuova formula magica per la ripartenza del lavoro. I provvedimenti governativi l’hanno lanciato, il dibattito fra le parti sociali s’è acceso su questa modalità organizzativa del lavoro. Gli entusiasti si sono lanciati in una serie innumerevole di webinar (i seminari via web che tanto impazzano) dedicati al lavoro smart, all’insegnamento smart, al nostro futuro della vita smart. In un crescendo incontrollato, sembra che tutto possa diventare smart. In realtà, non è una novità: lo è nella misura in cui finora non era stata considerata utile, né tanto meno applicata. Diversamente da altri paesi dove invece ha trovato maggiore diffusione, complice una struttura delle imprese mediamente più grande. Ma siamo così sicuri che il futuro del lavoro passi dalla diffusione dello smart working? Serve fare un po’ di chiarezza.
Un primo aggiustamento nelle rappresentazioni, però, è necessario, ora che siamo (o dovremmo essere) entrati in una fase di riprogettazione del futuro: perché un conto è immaginare un’organizzazione del lavoro in cui una parte degli occupati lavora in modalità “smart”; altro è ipotizzare il “telelavoro”. Nel primo caso non esistono orari definiti, ma si opera per obiettivi. Nel secondo, invece, si tratta di una trasposizione in ambito casalingo, con orari definiti e controllati. Due opzioni di culture organizzative assai diverse. La prima post-fordista e 4.0, la seconda ancora ispirata al fordismo. E con diritti, doveri e tutele altrettanto differenti.
In secondo luogo, sappiamo che una parte consistente del lavoro e dei lavoratori è uscito dalle sedi delle imprese. Ma quanti? Community Research&Analysis ha sondato i lavoratori dipendenti nel periodo di chiusura delle attività (lockdown). Sui 2,6 milioni di lavoratori del Nordest, poco più di 730mila (28,4%) dichiaravano di lavorare da casa. Poco più di 500mila (20,2%) erano in Cassa integrazione e quasi altrettanti stavano utilizzando le ferie (19,4%). Al lavoro normalmente (420mila circa) o a tempo ridotto (400mila circa) erano complessivamente il restante 32,0%. È utile aggiungere che esiste una forte diversità a seconda dei settori e delle dimensioni d’impresa, oltre alle caratteristiche sociali dei lavoratori. Ad esempio, poco più della metà fra i laureati (51,4%) ha sperimentato il lavoro da casa, mentre nessuno fra chi possiede l’obbligo o una certificazione professionale (2,0%).
La componente femminile (34,5%) è stata più coinvolta da questa esperienza rispetto ai colleghi maschi (29,2%), complice anche una loro maggiore collocazione nel settore dei servizi. Infatti, il telelavoro è stato assai più diffuso fra gli impiegati (41,0%), nelle imprese più grandi (51,3%, oltre i 250 addetti), mentre raramente ha coinvolto le micro (23,1%, fino a 9 addetti). Nell’industria solo il 15,6% ha spostato il lavoro fuori dall’ufficio, ma altrettanto è avvenuto per il 31,5% degli occupati dei servizi e ben 1 lavoratore su 2 (48,5%) del pubblico impego. In generale, nel Nordest il telelavoro è stato meno utilizzato (28,4%) rispetto ad altre realtà come il Nordovest (35,7%), in virtù di un tessuto imprenditoriale di dimensioni più contenuto.
Il telelavoro e, quando sarà realmente possibile, lo smart working, costituiscono “una” delle modalità di lavoro che potrà essere complementare a quello tradizionalmente svolto all’interno delle imprese. Ciò non toglie che diverse aziende ed enti pubblici, sulla scorta di questa esperienza stiano già rivisitando i propri assetti organizzativi sfruttando le potenzialità e i risparmi ottenuti.
Sicuramente, però, non sarà “la” norma perché si tratta di una soluzione che deve essere declinata sulla base delle peculiarità aziendali, del settore, del tipo di produzione o servizio. Non può essere una ricetta valida per tutti. È una modalità organizzativa che offre diverse opportunità: risparmio negli spostamenti, minore inquinamento, migliore gestione dei tempi di vita e di lavoro. Ma presenta altrettanti rischi: segregazione femminile, allungamento dei tempi di lavoro, abitazioni non attrezzate, scarsa connettività. Alimentando le polarizzazioni sul mercato e le disuguaglianze sociali.
Dunque, è necessario non disperdere l’esperienza preziosa fin qui fatta, valorizzandola al meglio per le sue conseguenze di sistema positive. Ma definendola nel modo più corretto. Se si vuole passare dal telelavoro al lavoro intelligente (smart working) servono forti investimenti nella formazione, nelle infrastrutture immateriali e nelle culture manageriali. —
* direttore scientifico
Research&Analysis
Community Group
Riproduzione riservata © Il Piccolo









